Gli scrittori servono a farci vedere delle cose che non vediamo. A farci avvertire dentro, in fondo a noi, delle cose che avevamo smesso di sentire. Servono a risvegliarci dall'anestesia, con le carezze o se serve anche con le sberle. Con i pugni nello stomaco. Con delle parole che fanno spazio al silenzio e alla riflessione. Più che rassicuranti e belli da leggere gli scrittori, più che compiacenti, dovrebbero saper essere qualche volta antipatici e presuntuosi, almeno questo è quello che penso io. "Se in Italia si dice di no, si è polemici. Se si mette in discussione una richiesta grottesca si è rompiscatole." Se non si è né polemici né rompiscatole, mai, il rischio concreto è quello di diventare paraculi e uno scrittore paraculo, sempre secondo quello che penso io, è uno scrittore che non serve. C'è un confine netto tra lavoro d'autore e pubblicità, tra corporate communication e narrazione e anche tra giornalismo serio e brand storytelling. E' una linea che si può decidere o meno di scavalcare e ci si può anche giocare a saltarello sopra, se uno lo desidera e ne è consapevole. Ma bisogna essere attrezzati e capaci di gestire la cosa e probabilmente attrezzati meglio di tutti - attrezzati a comprendere - dovrebbero essere i lettori e questo è un lavoro che si fa con la cultura e con la scuola. Se a scuola non ti insegnano la differenza, se qualcuno disinteressato non ti insegna a riconoscere quella linea, è dura. E poi di più ancora, più capaci e consapevoli ancora dovrebbero essere i comunicatori, quelli cioè che il lavoro degli autori e degli scrittori, le loro parole e le idee, le usano per professione per narrare brand e imprese. Per vendere, insomma. Comunicazione e narrazione, giornalismo e narrazione, content creation e reportage forse mai come adesso vivono una relazione ambigua. Pericolosa. Mi pare che siamo al punto in cui anche chi dovrebbe essere attrezzato, capace di comprendere dove è posizionata esattamente questa linea di confine, si capisce che non lo è. A forza di essere disinvolti sul tema non sappiamo più distinguere tra vero e verosimile, tra storytelling e informazione, tra persone e personaggi. Per fortuna che c'è qualche scrittore ogni tanto che oltre a scrivere dei bei libri dice anche delle cose che fanno riflettere, facendo delle cose "da rompiscatole", non necessariamente convenienti. Non sempre giusto e conveniente coincidono, se sei uno scrittore e sei nella cinquina finalista del Premio Strega ad esempio, e dici una cosa come quella che dice Matteo Nucci, ti metti cioè a dissertare su "defezione" e "non adesione" o su "comunicazione" e "pubblicità", che è un dettaglio che si mette inevitabilmente in conflitto con i tuoi interessi personali e con quelli della tua casa editrice e con quelli dell'organizzatore del Premio e con quelli di uno dei main sponsor del premio, devi necessariamente essere uno con una bella testa. E anche un rompicoglioni certo, ma mica deve essere facile. Meno male che c'è anche qualche scrittore così, che ha il coraggio di rendersi antipatico di riflettere ad alta voce. In fondo il mestiere dello scrittore è proprio questo, non ha mica a che fare con lo scrivere soltanto. Si tratta di fondare degli universi in cui ogni cosa occupi un proprio posto. Creare dei contesti di pensiero dentro cui gli altri possano ragionare. Poi l'essere d'accordo e allineati o meno, quello è un altro discorso. Il non-allineamento è un lusso che la scrittura e la lettura possono concedersi. Il marketing, no.
http://www.minimaetmoralia.it/wp/partecipare-al-premio-strega-significa-far-pubblicita-alla-toyota/
martedì 27 giugno 2017
lunedì 15 maggio 2017
sabato 6 maggio 2017
DO MORE.
Non so dove foste voi alle 5 e 45 di questa mattina, probabilmente a dormire. A Monza, sulla pista della F1, a quell'ora tre uomini - i tre migliori tra i migliori maratoneti in attività del pianeta - dopo sette mesi di preparazione specifica, di studio scientifico e di lavoro di squadra hanno messo sull'asfalto il loro tentativo di correre per 42 chilometri in meno di due ore, il record in gara è di 2h02'57".
Non si è trattato di una gara vera e propria ma di un esperimento scientifico, di un test su strada, di una tappa di avvicinamento al record in gara, chiamatelo come volete. E' stata anche una operazione pubblicitaria e di marketing - certo - a supportare tutto questo lavoro non c'era la IAAF, il CIO o la Federazione di Atletica Leggera ma una azienda privata con il suo capitale privato e con le sue migliori risorse: ricercatori, tecnici, preparatori, scienziati, materiali, nuovi prodotti. Il muro delle due ore questa mattina non è stato abbattuto ma Eliud Kipchoge ha corso la distanza della maratona in 2h00'25", un tempo strepitoso che ci proietta nel futuro della corsa.
E' stato fantastico vedere in diretta streaming alcuni tra i runner migliori del mondo fare da lepre a questi tre nel loro tentativo (oltre a Kipchoge c'erano anche Zersenay Tadese e Lesisa Desisa) alternandosi al comando in un perfetto lavoro di squadra, se non siete tra quelli che stamattina si sono alzati presto per guardare, beh, vi consiglio di rivedervi almeno gli ultimi chilometri, sono da pelle d'oca. Guardatevi la gioia e la partecipazione sincera, gli hi-five, il lavoro di squadra e l'affiatamento. Guardate bene e ricredetevi, se siete tra quelli che andavano dicendo che questa è una pagliacciata e che non è sport. Questo evento che tra dieci o venti o cinquant'anni andremo forse a rivedere in video mostrandolo ai nipoti come facciamo oggi con il record dell'ora di Moser a Città del Messico o con Roger Bannister che per primo nella storia corre il miglio in meno di quattro minuti, ci ha detto almeno quattro cose:
- 1, correre una maratona in meno di due ore è umanamente possibile, questo è un click mentale nella testa degli atleti che produrrà nei prossimi mesi dei risultati cronometrici strepitosi.
- 2, la corsa a piedi - anche quella di alto livello - è uno sport di squadra, proprio come il ciclismo, la pallavolo e le tapasciate tra amici che facciamo noi la domenica mattina.
- 3, c'è un modo nuovo di pensare allo sport e di essere sportivi e anche agonisti che non ha necessariamente a che fare con la competizione e con le federazioni ma che ha a che fare invece con l'esplorazione e con la scienza, con la scoperta di sé, con la gioia pura generata dallo spingersi oltre. Siamo passato da "Just do it" a "Do more" e questo è il passaggio a un epoca successiva (non solo in campo sportivo) che forse in molti non riescono a cogliere.
- 4, si è trattato in ultima analisi anche di un esperimento di marketing e sociale, questo è sicuro. Questo tentativo di record ha riguardato anche e soprattutto i detrattori, ha diviso il mondo in scettici ed entusiasti, in fondo lo sport è anche questo: libertà di non apprezzare o di non gioire.
Una infinità di persone (tra questi oltre che molti runner anche addetti ai lavori e giornalisti) si sono dichiarati apertamente in contrasto con questo tentativo, sembra quasi che a qualcuno dia fastidio che un certo ordine delle cose venga sovvertito a partire dalla verità oggettiva dei numeri che rappresentano il riscontro cronometrico.
Sembra che l'alone che circonda il record e la maratona, il suo mistero a la epica che le aleggia intorno sia per alcuni minacciato dalla cruda realtà statistica dei dati. La critica principale che ho colto a questo progetto è riassunta nella frase: "non è sport". Kipchoge, Tadese e Desisa hanno corso con le loro gambe mica in groppa a qualcuno quindi mi chiedo a questo punto che cosa è lo sport, per certi, ma a parte questo a me viene il dubbio che tutta questa ostilità che ho visto in certi casi sconfinare nel disprezzo dica una cosa soltanto: che questa è la strada giusta.
https://youtu.be/
Non si è trattato di una gara vera e propria ma di un esperimento scientifico, di un test su strada, di una tappa di avvicinamento al record in gara, chiamatelo come volete. E' stata anche una operazione pubblicitaria e di marketing - certo - a supportare tutto questo lavoro non c'era la IAAF, il CIO o la Federazione di Atletica Leggera ma una azienda privata con il suo capitale privato e con le sue migliori risorse: ricercatori, tecnici, preparatori, scienziati, materiali, nuovi prodotti. Il muro delle due ore questa mattina non è stato abbattuto ma Eliud Kipchoge ha corso la distanza della maratona in 2h00'25", un tempo strepitoso che ci proietta nel futuro della corsa.
E' stato fantastico vedere in diretta streaming alcuni tra i runner migliori del mondo fare da lepre a questi tre nel loro tentativo (oltre a Kipchoge c'erano anche Zersenay Tadese e Lesisa Desisa) alternandosi al comando in un perfetto lavoro di squadra, se non siete tra quelli che stamattina si sono alzati presto per guardare, beh, vi consiglio di rivedervi almeno gli ultimi chilometri, sono da pelle d'oca. Guardatevi la gioia e la partecipazione sincera, gli hi-five, il lavoro di squadra e l'affiatamento. Guardate bene e ricredetevi, se siete tra quelli che andavano dicendo che questa è una pagliacciata e che non è sport. Questo evento che tra dieci o venti o cinquant'anni andremo forse a rivedere in video mostrandolo ai nipoti come facciamo oggi con il record dell'ora di Moser a Città del Messico o con Roger Bannister che per primo nella storia corre il miglio in meno di quattro minuti, ci ha detto almeno quattro cose:
- 1, correre una maratona in meno di due ore è umanamente possibile, questo è un click mentale nella testa degli atleti che produrrà nei prossimi mesi dei risultati cronometrici strepitosi.
- 2, la corsa a piedi - anche quella di alto livello - è uno sport di squadra, proprio come il ciclismo, la pallavolo e le tapasciate tra amici che facciamo noi la domenica mattina.
- 3, c'è un modo nuovo di pensare allo sport e di essere sportivi e anche agonisti che non ha necessariamente a che fare con la competizione e con le federazioni ma che ha a che fare invece con l'esplorazione e con la scienza, con la scoperta di sé, con la gioia pura generata dallo spingersi oltre. Siamo passato da "Just do it" a "Do more" e questo è il passaggio a un epoca successiva (non solo in campo sportivo) che forse in molti non riescono a cogliere.
- 4, si è trattato in ultima analisi anche di un esperimento di marketing e sociale, questo è sicuro. Questo tentativo di record ha riguardato anche e soprattutto i detrattori, ha diviso il mondo in scettici ed entusiasti, in fondo lo sport è anche questo: libertà di non apprezzare o di non gioire.
Una infinità di persone (tra questi oltre che molti runner anche addetti ai lavori e giornalisti) si sono dichiarati apertamente in contrasto con questo tentativo, sembra quasi che a qualcuno dia fastidio che un certo ordine delle cose venga sovvertito a partire dalla verità oggettiva dei numeri che rappresentano il riscontro cronometrico.
Sembra che l'alone che circonda il record e la maratona, il suo mistero a la epica che le aleggia intorno sia per alcuni minacciato dalla cruda realtà statistica dei dati. La critica principale che ho colto a questo progetto è riassunta nella frase: "non è sport". Kipchoge, Tadese e Desisa hanno corso con le loro gambe mica in groppa a qualcuno quindi mi chiedo a questo punto che cosa è lo sport, per certi, ma a parte questo a me viene il dubbio che tutta questa ostilità che ho visto in certi casi sconfinare nel disprezzo dica una cosa soltanto: che questa è la strada giusta.
https://youtu.be/
lunedì 1 maggio 2017
UELI.
E' una gioia testimoniare il genio di un fuoriclasse quando questo si rivela. Un fuoriclasse mette tutti d'accordo perché gioca a un livello così alto, fa un uso dello spazio e del tempo così differente dal tuo, si muove in un ordine di grandezze così grande che può sperimentare cose che tu non sei in grado nemmeno di vedere e che senza di lui, tu, non potresti nemmeno immaginare.
Se sei fortunato, se lui il fuoriclasse ti fa il regalo di spiegarsi e di raccontare, di aprirsi e di condividere, ti può portare con sé. Può farti partecipe del suo talento e mostrarti un altro universo, una realtà parallela in cui le cose succedono secondo logiche diverse, in modo diverso, a te non resta che rimanere in silenzio ed ascoltare. Provare a capire. Provare a fare come lui, nel tuo piccolo e la cosa straordinaria è che quasi sempre funziona, serve allenarsi e crederci. Mettersi in gioco.
La conquista dei fuoriclasse per noi è mostrarci la via, in fondo il fascino del grande alpinismo è proprio questo: la meraviglia. I fuoriclasse tutto quello che fanno è smontare la parola impossibile in tanti pezzetti più piccoli, in tanti piccoli possibile da mettere insieme, forse è questo in alpinismo il vero e unico significato della parola conquista: andare oltre e prendere, portare indietro a beneficio degli altri. E' un passaggio di consegne.
Raccontare e condividere costa fatica e certe volte richiede coraggio ma è uno sforzo necessario per progredire e per dare un senso a tutti quei rischi che hai corso e a quell'essersi sentito insignificante e minuscolo a un certo punto, "più morto che vivo, in quello spazio invisibile tra la terra e il cielo". E’ così che l’aveva descritto ed è così che al ritorno ci ha detto di essersi sentito alcune volte, Ueli Steck.
Dobbiamo dirgli grazie per tutto quello che ci ha mostrato e per tutto quello che ci ha detto. Per l’esempio. Per avere avuto voglia di portarci con lui. Per il suo essere così indiscutibilmente migliore di noi e per averci tenuto lo stesso vicini, con lui, mostrandoci la via e raccontandoci anche quello che era perfino difficile credere. E' un vero peccato che sia finita qui, oggi. E' un peccato per lui e anche per noi.
Quando succede che un fuoriclasse dell'alpinismo se ne va ad andarsene c'è anche un pezzo di noi, succede perché sono talenti così grandi che noi ci sentiamo loro. Noi "siamo" loro, nel nostro piccolo, comprendiamo di poter essere un’altra cosa. E' per questo che sapere che Ueli non c’è più adesso ci fa così male: perché oggi è morto anche anche qualcosa di noi. Oggi insieme ad Ueli se ne è andato un pezzo di alpinismo, che è stato e che poteva essere.
Grazie di tutto, Maestro.
Se sei fortunato, se lui il fuoriclasse ti fa il regalo di spiegarsi e di raccontare, di aprirsi e di condividere, ti può portare con sé. Può farti partecipe del suo talento e mostrarti un altro universo, una realtà parallela in cui le cose succedono secondo logiche diverse, in modo diverso, a te non resta che rimanere in silenzio ed ascoltare. Provare a capire. Provare a fare come lui, nel tuo piccolo e la cosa straordinaria è che quasi sempre funziona, serve allenarsi e crederci. Mettersi in gioco.
La conquista dei fuoriclasse per noi è mostrarci la via, in fondo il fascino del grande alpinismo è proprio questo: la meraviglia. I fuoriclasse tutto quello che fanno è smontare la parola impossibile in tanti pezzetti più piccoli, in tanti piccoli possibile da mettere insieme, forse è questo in alpinismo il vero e unico significato della parola conquista: andare oltre e prendere, portare indietro a beneficio degli altri. E' un passaggio di consegne.
Raccontare e condividere costa fatica e certe volte richiede coraggio ma è uno sforzo necessario per progredire e per dare un senso a tutti quei rischi che hai corso e a quell'essersi sentito insignificante e minuscolo a un certo punto, "più morto che vivo, in quello spazio invisibile tra la terra e il cielo". E’ così che l’aveva descritto ed è così che al ritorno ci ha detto di essersi sentito alcune volte, Ueli Steck.
Dobbiamo dirgli grazie per tutto quello che ci ha mostrato e per tutto quello che ci ha detto. Per l’esempio. Per avere avuto voglia di portarci con lui. Per il suo essere così indiscutibilmente migliore di noi e per averci tenuto lo stesso vicini, con lui, mostrandoci la via e raccontandoci anche quello che era perfino difficile credere. E' un vero peccato che sia finita qui, oggi. E' un peccato per lui e anche per noi.
Quando succede che un fuoriclasse dell'alpinismo se ne va ad andarsene c'è anche un pezzo di noi, succede perché sono talenti così grandi che noi ci sentiamo loro. Noi "siamo" loro, nel nostro piccolo, comprendiamo di poter essere un’altra cosa. E' per questo che sapere che Ueli non c’è più adesso ci fa così male: perché oggi è morto anche anche qualcosa di noi. Oggi insieme ad Ueli se ne è andato un pezzo di alpinismo, che è stato e che poteva essere.
Grazie di tutto, Maestro.
sabato 29 aprile 2017
DI MEZZE PIPPE, DI TELEMARK E DI FUNAMBOLISMO.
Ora sarò lungo e noioso. Serio. Parlerò di telemark e del perché a mio parere i nuovi attacchi che offrono anche la possibilità di bloccare il tallone, sono la morte del telemark.
Dell'aspetto tecnico ho già detto altre volte, riassumo: disponibili ci sono 3 attacchi e mezzo, tutti estremamente differenti tra loro per quanto riguarda l'esperienza di sciata telemark che si può realizzare, la sensazione d'uso è completamente differente nei tre casi, ognuno sul tema arriverà alle propria conclusioni, essenziali sono però due cose: uno, provarli tutti; due, essere capaci di sciare bene altrimenti le conclusioni a cui uno arriva sono un po' strampalate, lo vedo succedere spesso.
Il discorso della talloniera e della influenza sulla "testa" dello sciatore di cui sento spesso parlare invece (la talloniera supplementare è una alternativa di sicurezza) è per me il fattore più importante e interessante della intera faccenda e la mia opinione è - mi pare - in controtendenza rispetto a quella di molto.
La maggior parte di noi - è ciò che accomuna i telemarker - scia a telemark per via dell'esperienza collegata all gesto e per la gioia che l'apprendimento e la progressione tecnica ci riservano. Il telemark oltre che una tecnica è - a mio modo di vedere - un modo di guardare ai problemi: ciascuno di noi è chiamato a prendere atto della assenza della talloniera e a risolvere la questione (che è il postulato di base del telemark) escogitando delle soluzioni alternative.
La maggior parte delle soluzioni di alcuni di noi hanno a che fare con gli aspetti tecnici e di ingegneria della faccenda ma si tratta a mio parere il modo sbagliato di guardare al problema, specialmente per uno che non ha ancora raggiunto il proprio limite tecnico e sportivo ( detto brutalmente per una mezza pippa del telemark, con tutto il rispetto e la simpatia per essere mezza pippa, ci siamo passati tutti). Mi pare che più uno è "scarso" più in genere, all'inizio, tenta di risolvere i suoi problemi tecnici affidandosi ai materiali e alla tecnologia.
Tutti sappiamo o dovremmo sapere che lo sci alpino è meccanicamente e bio-meccabicamente più efficiente del telemark, è un dato di fatto, la risposta in termini di efficienza per una sciata migliore dal punto di vista della meccanica e della biomeccanica è "bloccare il tallone" come si fa da quasi un secolo con lo sci alpino, la soluzione tecnologica c'è già. Ma perseverando con il tallone libero per scelta e per puro esercizio della volontà, insistendo, rimettendo in discussione le nostre certezze, pazientando e sgobbando un sacco, a volte rinunciando a prendere delle scorciatoie, accadono delle cose meravigliose. Metti cera, togli cera. Metti cera, togli cera. Il telemark è qualcosa che essenzialmente avviene nella testa di ciascuno di noi, è una idea soprattutto. Un gioco. Un esperimento. Un tentativo. Se uno elimina la difficoltà alla base del telemark e la possibilità di errore, cioè la possibilità del fallimento, il telemark non esiste più, sparisce. Puff.
Fare telemark è come fare il funambolo, è una cosa inutile e superflua. Pericolosa. Scomoda. Barocca. Certe volte perfino scocciante, per chi lo fa e per chi lo vede fare. Se a un funambolo chiediamo come si fa ad attraversare l'aria che separa due palazzi a centinaia di metri da terra lui andrà per eliminazione, ci dirà prima del ballerino sulla corda e poi del filferrista e infine, del funambolo:
"Fa uno spettacolo che è simile al gioco d'azzardo. E' fiero della propria paura. Osa tendere cavi sui precipizi, si lancia all'assalto dei campanili, allontana e unisce le montagne. Il suo cavo d'acciaio, la sua corda, deve essere tesa all'estremo. Compie grandi traversate, servendosi di un bilancere. E' il ladro del Medioevo. E' il funambolo." - Philippe Petit, Trattato di Funambolismo.
Il telemark è sport ma anche non è sport. E' tecnica ma non è tecnica. E' funambolismo.
Se cammini su una corda tesa senza possibilità di cadere, stando attaccato al muro, che cosa lo fai a fare?
Dell'aspetto tecnico ho già detto altre volte, riassumo: disponibili ci sono 3 attacchi e mezzo, tutti estremamente differenti tra loro per quanto riguarda l'esperienza di sciata telemark che si può realizzare, la sensazione d'uso è completamente differente nei tre casi, ognuno sul tema arriverà alle propria conclusioni, essenziali sono però due cose: uno, provarli tutti; due, essere capaci di sciare bene altrimenti le conclusioni a cui uno arriva sono un po' strampalate, lo vedo succedere spesso.
Il discorso della talloniera e della influenza sulla "testa" dello sciatore di cui sento spesso parlare invece (la talloniera supplementare è una alternativa di sicurezza) è per me il fattore più importante e interessante della intera faccenda e la mia opinione è - mi pare - in controtendenza rispetto a quella di molto.
La maggior parte di noi - è ciò che accomuna i telemarker - scia a telemark per via dell'esperienza collegata all gesto e per la gioia che l'apprendimento e la progressione tecnica ci riservano. Il telemark oltre che una tecnica è - a mio modo di vedere - un modo di guardare ai problemi: ciascuno di noi è chiamato a prendere atto della assenza della talloniera e a risolvere la questione (che è il postulato di base del telemark) escogitando delle soluzioni alternative.
La maggior parte delle soluzioni di alcuni di noi hanno a che fare con gli aspetti tecnici e di ingegneria della faccenda ma si tratta a mio parere il modo sbagliato di guardare al problema, specialmente per uno che non ha ancora raggiunto il proprio limite tecnico e sportivo ( detto brutalmente per una mezza pippa del telemark, con tutto il rispetto e la simpatia per essere mezza pippa, ci siamo passati tutti). Mi pare che più uno è "scarso" più in genere, all'inizio, tenta di risolvere i suoi problemi tecnici affidandosi ai materiali e alla tecnologia.
Tutti sappiamo o dovremmo sapere che lo sci alpino è meccanicamente e bio-meccabicamente più efficiente del telemark, è un dato di fatto, la risposta in termini di efficienza per una sciata migliore dal punto di vista della meccanica e della biomeccanica è "bloccare il tallone" come si fa da quasi un secolo con lo sci alpino, la soluzione tecnologica c'è già. Ma perseverando con il tallone libero per scelta e per puro esercizio della volontà, insistendo, rimettendo in discussione le nostre certezze, pazientando e sgobbando un sacco, a volte rinunciando a prendere delle scorciatoie, accadono delle cose meravigliose. Metti cera, togli cera. Metti cera, togli cera. Il telemark è qualcosa che essenzialmente avviene nella testa di ciascuno di noi, è una idea soprattutto. Un gioco. Un esperimento. Un tentativo. Se uno elimina la difficoltà alla base del telemark e la possibilità di errore, cioè la possibilità del fallimento, il telemark non esiste più, sparisce. Puff.
Fare telemark è come fare il funambolo, è una cosa inutile e superflua. Pericolosa. Scomoda. Barocca. Certe volte perfino scocciante, per chi lo fa e per chi lo vede fare. Se a un funambolo chiediamo come si fa ad attraversare l'aria che separa due palazzi a centinaia di metri da terra lui andrà per eliminazione, ci dirà prima del ballerino sulla corda e poi del filferrista e infine, del funambolo:
"Fa uno spettacolo che è simile al gioco d'azzardo. E' fiero della propria paura. Osa tendere cavi sui precipizi, si lancia all'assalto dei campanili, allontana e unisce le montagne. Il suo cavo d'acciaio, la sua corda, deve essere tesa all'estremo. Compie grandi traversate, servendosi di un bilancere. E' il ladro del Medioevo. E' il funambolo." - Philippe Petit, Trattato di Funambolismo.
Il telemark è sport ma anche non è sport. E' tecnica ma non è tecnica. E' funambolismo.
Se cammini su una corda tesa senza possibilità di cadere, stando attaccato al muro, che cosa lo fai a fare?
Etichette:
cosecomplicate,
freeridermagazine,
freeriding,
ski,
telemark
lunedì 10 aprile 2017
TRACCE
In cima al Bec des Rosses non sei uno qualunque, ti ci hanno mandato. Ne hanno chiamati sedici da tutto il mondo e uno di quei sedici, sei tu. In un certo senso sei uno a cui sta per essere affidata una piccola porzione di mondo e che dovrà prendersene cura. Reinventarla o provarci, almeno. Interpretarla. Custodirla. Far capire che esiste, in fondo tutto quello che ti si chiede è di sciare e di fare di quello spazio un luogo, costruire una storia e offrirla agli altri, è la stessa cosa che si chiede a uno scultore o a un architetto: dare un senso alle tre dimensioni mettendoci dentro una visione.
C’è questa grande parete nord, il Bec des Rosses e ci sei tu e tutto quello che devi fare è disegnare la tua linea, anzi non la devi disegnare: la devi scolpire. Devi scendere, come vuoi. In snowboard. Adesso ci sono anche quelli con gli sci ma quando hanno invitato a partecipare me quasi venti anni fa, quelli non c’erano, c’eravamo solo noi. Che vi piaccia o no è dagli snowboarder che è iniziata la rivoluzione del freeride e dello sci così come lo intendiamo adesso. Tu, in gara, la tua traccia puoi farla andare dove vuoi, sul ripido esposto che se cadi muori o a zigo-zago per la parete cercando i cliff. Puoi andare veloce oppure lento, ricavare curve dentro a quegli spazi bianchi compresi tra le rocce oppure puoi tentare di andare dritto se ne sei capace, se hai pelo abbastanza. Qualcuno è così bravo che ce la fa. Puoi fare quello che vuoi. In ogni caso: tutto quello che farai, ogni mossa, ogni esitazione, ogni incertezza, ogni magia che tirerai fuori dal cappello, qualsiasi cosa ti verrà in mente di fare dal basso sarà visibile a chiunque. All’Xtreme di Verbier non puoi barare. Ci sei tu e c’è la montagna e c'è anche il pubblico. Ti guardano. Stanno di fronte della parete, lontani e apparentemente ininfluenti ma ci sono, senti le voci arrivare da sotto portate dal vento. Sono lì.
E' una sensazione strana, sei solo ma anche non sei solo, non c'è niente di paragonabile al mondo tranne forse quelle discese che capita di fare in cui ti vedono dalla funivia, è come stare dentro a un acquario ma all'incontrario: quelli ti guardano e tu sei un pesce solitario e nuoti, ma non dentro all'acquario. Dentro all'acquario in quel mondo recintato e artificiale, chiusi, ci stanno loro. Tu sei libero. Solo. Sei l'unico abitante del mondo. Sul Bec des Rosses puoi soltanto scendere, fare quello che sai, possibilmente non ammazzarti e divertirti. Scendi e poi alla fine, non subito ma anni dopo, ti accorgi che non sei tu ad avere lasciato la tua linea.
E' il Bec des Rosses che in fin dei conti, ha tracciato te.
leggi e guarda le foto su facebook
C’è questa grande parete nord, il Bec des Rosses e ci sei tu e tutto quello che devi fare è disegnare la tua linea, anzi non la devi disegnare: la devi scolpire. Devi scendere, come vuoi. In snowboard. Adesso ci sono anche quelli con gli sci ma quando hanno invitato a partecipare me quasi venti anni fa, quelli non c’erano, c’eravamo solo noi. Che vi piaccia o no è dagli snowboarder che è iniziata la rivoluzione del freeride e dello sci così come lo intendiamo adesso. Tu, in gara, la tua traccia puoi farla andare dove vuoi, sul ripido esposto che se cadi muori o a zigo-zago per la parete cercando i cliff. Puoi andare veloce oppure lento, ricavare curve dentro a quegli spazi bianchi compresi tra le rocce oppure puoi tentare di andare dritto se ne sei capace, se hai pelo abbastanza. Qualcuno è così bravo che ce la fa. Puoi fare quello che vuoi. In ogni caso: tutto quello che farai, ogni mossa, ogni esitazione, ogni incertezza, ogni magia che tirerai fuori dal cappello, qualsiasi cosa ti verrà in mente di fare dal basso sarà visibile a chiunque. All’Xtreme di Verbier non puoi barare. Ci sei tu e c’è la montagna e c'è anche il pubblico. Ti guardano. Stanno di fronte della parete, lontani e apparentemente ininfluenti ma ci sono, senti le voci arrivare da sotto portate dal vento. Sono lì.
E' una sensazione strana, sei solo ma anche non sei solo, non c'è niente di paragonabile al mondo tranne forse quelle discese che capita di fare in cui ti vedono dalla funivia, è come stare dentro a un acquario ma all'incontrario: quelli ti guardano e tu sei un pesce solitario e nuoti, ma non dentro all'acquario. Dentro all'acquario in quel mondo recintato e artificiale, chiusi, ci stanno loro. Tu sei libero. Solo. Sei l'unico abitante del mondo. Sul Bec des Rosses puoi soltanto scendere, fare quello che sai, possibilmente non ammazzarti e divertirti. Scendi e poi alla fine, non subito ma anni dopo, ti accorgi che non sei tu ad avere lasciato la tua linea.
E' il Bec des Rosses che in fin dei conti, ha tracciato te.
leggi e guarda le foto su facebook
Etichette:
alpinismo,
freeridermagazine,
freeriding,
ski
mercoledì 22 marzo 2017
venerdì 11 novembre 2016
LA FABBRICA DELLA FRUSTRAZIONE.
Tutte le volte che mi capita di sciare con uno attaccato alle mie code che vuole verificare di persona se io, effettivamente, meritavo di sciare e di scalare per tutta la mia vita per professione (ce n'è più di quanti credete, di questi soggetti) penso che è esattamente così che funziona il mondo.
Mi pare che sia secondo questo principio che una testa di minchia qualsiasi si convince, perché ha speso buona parte delle giornate della sua vita davanti a un computer a parlare di big mountain skiing e di grande alpinismo con altri soggetti abbastanza sfigati come come lui, di saperne sempre una pagina più del libro. Gli altri gli tributano grande competenza, per forza spesso ne sanno meno di lui. La Natura è pronta a mangiarselo in un solo boccone.
"Se io sostituisco al parere di un esperto quello di un milione di gente inesperta che però una sua idea ce l'ha, arrivo più vicino alla verità, ci arrivo più velocemente, ci arrivo spendendo meno soldi e ci arrivo in un modo che mi dà una certa idea di libertà: di fatto, una situazione irresistibile.
Google funziona, grosso modo, su questo principio logico.
Ora, attenzione: la vera conseguenza di questo processo è solo una, e non è che vi prenotate gli alberghi da soli (quello è un dettaglio): la vera conseguenza è che da qualche anno la gente si sta allenando a fare a meno degli esperti, cioè delle élite. Ti alleni per anni in piccole cose (la scelta del ristorante, la cura per il piede dello sportivo, le ricerche copiate da Wikipedia) e inizi ad acquisire una certa sicurezza di te e soprattutto: una silenziosa capacità di ribellarti alle élite. Non a quelle economiche, quella è un'altra storia, lì dormiamo tutti un sonno profondo. Parliamo di élite culturali: quelli che hanno studiato, quelli che sanno.
Nel tempo accumuli anche la sorda convinzione di essere stato per lungo tempo vittima di una truffa: se te la puoi cavare benissimo senza quelle élite, evidentemente per anni quelli ti hanno fregato, portandoti via soldi, tempo, controllo sulla tua vita, indipendenza, libertà. Caricato a molla in questo modo, guardi la tua vita: è quel che è. Dato che l'Occidente usa come strategia di sviluppo l'imporre modelli performativi altissimi, facile che, a guardarti bene intorno, un po' tutto risulti vagamente fané, deludente, miserello."
Alessandro Baricco, su Repubblica del 10/11/2016
Etichette:
alpinismo,
cosecomplicate,
holden,
tempodielezioni
giovedì 12 maggio 2016
PORTE.
A casa mia, dove abitavo prima, vicino alla porta principale per uscire sul pianerottolo c’era una porta che andava in un’altra stanza, una stanza dove dormiva mio figlio e dove appesi al muro c’erano i suoi disegni. Disegni fatti a pastello e a pennarello. Succedeva spessissimo che quando qualcuno veniva a trovarci a casa, dopo esserci salutati, quando questo qualcuno se ne stava andando via sbagliava a prendere la porta e invece che andare fuori sul pianerottolo e chiamare l’ascensore, apriva la porta della stanza di mio figlio e ci entrava dentro. Certe volte succedeva anche - alla sera, dopo a delle cene ad esempio - che questo o questi ospiti che ci venivano a trovare andavano via quando mio figlio era già andato a dormire, quindi la stanza in quei casi se tentavano di entrarci dentro era completamente buia.
La scena di queste persone che sbagliavano a me e mia moglie ha sempre fatto ridere, all’inizio quando vedevamo uno afferrare la maniglia della porta sbagliata ci affrettavamo a indicargli la porta giusta, lo correggevamo e facevamo tutti una bella risata, poi dopo un po’ invece abbiamo iniziato a lasciare fare e a vedere cosa succedeva. Io soprattutto, ho iniziato a lasciar fare, mia moglie di meno. Anzi, devo ammettere che speravo sempre con tutte le mie forze che il mio ospite nell’andare via sbagliasse porta, così, per vedere cosa succedeva. Per me era una specie di test divertente. Quello che può succedere in questi casi non è mai una cosa scontata.
Una volta uno mi ha stretto la mano e mi ha salutato e poi è entrato nella stanza di mio figlio e si è richiuso la porta alle spalle. Io sono rimasto lì in piedi, aspettavo di vedere la sua faccia quando usciva, infatti dopo due secondi è uscito e mi ha detto “Forse ho sbagliato uscita?” Forse. Un altra volta un’altro, uno di quelli in giacca e cravatta che sembra che lavorano solo loro e che sono intelligenti soltanto loro (uno che proponeva degli investimenti) mi ha stretto la mano, mi ha augurato buon lavoro (ero in ciabatte, pantaloncini e maglietta) ha imboccato l’uscita (quella sbagliata) e si è infilato nella stanza di mio figlio, chiudendosi la porta alle spalle. Io come al solito sono rimasto lì in piedi ad aspettare. Dopo una decina di secondi visto che non veniva fuori ho aperto la porta, per capire quello che succedeva lì dentro e lui era lì, davanti alla finestra con una mano nella tasca dei pantaloni che digitava sui tasti del telefonino. Io l’ho guardato con sguardo interrogativo e lui ha guardato me e poi ha guardato l’armadio ma non come si guarda agli armadi, piuttosto come si guarda agli ascensori. Ha cercato i tasti per la chiamata dell’ascensore e non trovandoli, trovando invece sul letto di mio figlio il suo pupazzo di Winnie-the-Pooh, un po’ confuso mi ha chiesto: “L’ascensore?”.
Un’altra volta invece, stessa scena, una sera dopo una cena una coppia di nostri amici si è rivestita con il cappotto e le sciarpe per andare via, ci siamo abbracciati e salutati per una volta ancora e poi entrambi si sono infilati nella stanza dove stava dormendo mio figlio. Hanno richiuso la porta. Quando abbiamo riaperto tre secondi dopo erano nella stanza completamente buia, abbiamo acceso la luce e entrambi avevano due occhi sbarrati che sembravano due che erano stati rapiti dagli extraterrestri. Io ridevo come un pazzo, loro no, almeno all’inizio. Poi, sì.
Nel posto dove lavoro adesso un giorno sì e uno no succede circa la stessa cosa che succedeva a casa mia, ci sono due porte vicine messe ad angolo, una è pesante e di metallo e ha il maniglione antipatico e va verso l’uscita e c’è anche scritto USCITA, in grande, l’altra invece ha lo stesso colore ma è una porta di legno che va in uno sgabuzzino dove c’è il server. E’ incredibile notare come quasi tutti quelli che vengono per la prima volta a trovarci trovano più facile imboccare la porta dello stanzino del server invece che l'uscita.
Lo stanzino è buio e dentro ci sono un sacco di spie e di lucine colorate azzurre, verdine, viola che si accendono e si spengono. Finora ho visto molte persone che aprono e poi si accorgono quasi subito dell’apparecchiatura del server e dello sbaglio. Rido, ridiamo. Un paio li ho visti anche cercare di entrare.
Uno - lo giuro - era il periodo di Natale e degli alberi di Natale, si è buttato dentro dicendo “Uh, che giornate corte. C’è già buio”.
Era circa mezzogiorno.
La scena di queste persone che sbagliavano a me e mia moglie ha sempre fatto ridere, all’inizio quando vedevamo uno afferrare la maniglia della porta sbagliata ci affrettavamo a indicargli la porta giusta, lo correggevamo e facevamo tutti una bella risata, poi dopo un po’ invece abbiamo iniziato a lasciare fare e a vedere cosa succedeva. Io soprattutto, ho iniziato a lasciar fare, mia moglie di meno. Anzi, devo ammettere che speravo sempre con tutte le mie forze che il mio ospite nell’andare via sbagliasse porta, così, per vedere cosa succedeva. Per me era una specie di test divertente. Quello che può succedere in questi casi non è mai una cosa scontata.
Una volta uno mi ha stretto la mano e mi ha salutato e poi è entrato nella stanza di mio figlio e si è richiuso la porta alle spalle. Io sono rimasto lì in piedi, aspettavo di vedere la sua faccia quando usciva, infatti dopo due secondi è uscito e mi ha detto “Forse ho sbagliato uscita?” Forse. Un altra volta un’altro, uno di quelli in giacca e cravatta che sembra che lavorano solo loro e che sono intelligenti soltanto loro (uno che proponeva degli investimenti) mi ha stretto la mano, mi ha augurato buon lavoro (ero in ciabatte, pantaloncini e maglietta) ha imboccato l’uscita (quella sbagliata) e si è infilato nella stanza di mio figlio, chiudendosi la porta alle spalle. Io come al solito sono rimasto lì in piedi ad aspettare. Dopo una decina di secondi visto che non veniva fuori ho aperto la porta, per capire quello che succedeva lì dentro e lui era lì, davanti alla finestra con una mano nella tasca dei pantaloni che digitava sui tasti del telefonino. Io l’ho guardato con sguardo interrogativo e lui ha guardato me e poi ha guardato l’armadio ma non come si guarda agli armadi, piuttosto come si guarda agli ascensori. Ha cercato i tasti per la chiamata dell’ascensore e non trovandoli, trovando invece sul letto di mio figlio il suo pupazzo di Winnie-the-Pooh, un po’ confuso mi ha chiesto: “L’ascensore?”.
Un’altra volta invece, stessa scena, una sera dopo una cena una coppia di nostri amici si è rivestita con il cappotto e le sciarpe per andare via, ci siamo abbracciati e salutati per una volta ancora e poi entrambi si sono infilati nella stanza dove stava dormendo mio figlio. Hanno richiuso la porta. Quando abbiamo riaperto tre secondi dopo erano nella stanza completamente buia, abbiamo acceso la luce e entrambi avevano due occhi sbarrati che sembravano due che erano stati rapiti dagli extraterrestri. Io ridevo come un pazzo, loro no, almeno all’inizio. Poi, sì.
Nel posto dove lavoro adesso un giorno sì e uno no succede circa la stessa cosa che succedeva a casa mia, ci sono due porte vicine messe ad angolo, una è pesante e di metallo e ha il maniglione antipatico e va verso l’uscita e c’è anche scritto USCITA, in grande, l’altra invece ha lo stesso colore ma è una porta di legno che va in uno sgabuzzino dove c’è il server. E’ incredibile notare come quasi tutti quelli che vengono per la prima volta a trovarci trovano più facile imboccare la porta dello stanzino del server invece che l'uscita.
Lo stanzino è buio e dentro ci sono un sacco di spie e di lucine colorate azzurre, verdine, viola che si accendono e si spengono. Finora ho visto molte persone che aprono e poi si accorgono quasi subito dell’apparecchiatura del server e dello sbaglio. Rido, ridiamo. Un paio li ho visti anche cercare di entrare.
Uno - lo giuro - era il periodo di Natale e degli alberi di Natale, si è buttato dentro dicendo “Uh, che giornate corte. C’è già buio”.
Era circa mezzogiorno.
Etichette:
coselunghe,
cosestrane,
storielline
giovedì 18 febbraio 2016
FRENI, NIENTE.
Ieri sono stato ad allenarmi al velodromo ed è stato bellissimo, non parlo solo dell’esperienza sportiva, parlo dei pensieri che mi sono portato a casa dopo l’allenamento, oltre alle gambe a pezzi ovviamente. Mentre me ne tornavo a casa in macchina guardando fuori dal finestrino pensavo che è sempre più frequente parlando di sicurezza - in valanga, in montagna ma più in generale nella vita - imbattersi in esperti o presunti tali che pensano in nome della sicurezza di potere avere sempre e comunque un buon motivo per mettere dei divieti o per complicare le cose. Soggetti abbastanza ottusi e retrogradi che si credono invece all’avanguardia e che pensano che la sicurezza abbia sempre e soltanto a che fare con l’aggiungere e con il complicare, quasi mai con il levare o con il semplificare. Persone che assegnano grande valore agli oggetti e alla tecnologia, alle cose e ai gingilli tecnologici e quasi nessun valore alle persone, alla abilità, alla creatività e alla fantasia individuale. A queste persone pensavo ieri, tornerebbe molto utile qualche giro di pista in un velodromo, per certi versi è una esperienza illuminante. Le bici da pista sono semplicissime nella costruzione e nel funzionamento, sono tutte rigorosamente senza freni e questa è paradossalmente la condizione essenziale per la sicurezza di tutti i ciclisti nel gruppo: non frenare. Mai. Pedalare in pista avendo a disposizione i freni consentirebbe sempre a qualcuno di sentirsi autorizzato ad usarli, in caso di emergenza. Ognuno ha una idea propria, soggettiva e arbitraria di emergenza e la sicurezza è per natura una questione relativa, legata ai punti di vista. Alcuni di noi pretendono invece di pensarla come un valore assoluto o un diritto, la sicurezza, come una serie di limiti fissi da non oltrepassare mai, però non è così. Non basta, non funziona. La sicurezza è un fatto personale e non è mai un diritto, è una scelta. Una possibilità. E’ la somma algebrica di un calcolo che tiene conto di costi e benefici, di metodo e casualità, di abilità e di incapacità. I velodromi come le montagne non sono luoghi esenti da rischi, si pedala veloci, a distanza molto ravvicinata, ci si sorpassa e ci si insegue e le curve sono piuttosto inclinate, andando piano è perfino difficile restare in equilibrio. Pedalare in pista per un neofita è piuttosto destabilizzante, difficile. E poi appunto, le bici sono senza freni. Per pedalare in un velodromo bisogna accettare un certo grado di rischio e farlo proprio, prendere o lasciare. Minimizzare i rischi vuol dire in realtà accoglierli e gestirli, non eluderli. Non aggirarli. Non eliminarli. Si fa sempre fatica a dire a certi che pretenderebbero di decidere per tutti che non è vero che in nome della sicurezza tutto è lecito. Leggi, regolamenti, divieti, norme restrittive, accessori, modalità, tecnologie, controllo, limiti. Freni sulle bici. Se chiedete a uno che non ha mai pedalato in un velodromo se è più sicura una bici senza freni o una con i freni cosa volete che vi risponda? Percezione e realtà non sono la stessa cosa. La sicurezza certe volte - certe volte soltanto - ha a che fare con con il fare-di-più e con l’aggiungere, e certe altre volte ha a che fare con il non-fare e con il togliere. I freni, ad esempio.
lunedì 16 novembre 2015
SCIARE DUE VOLTE. [per chi non l'ha già letto]
La prima volta sci scia con i piedi. La seconda volta si scia con il cuore.
SCIARE DUE VOLTE.
Etichette:
freeriding,
medium,
scorribnde,
ski
TAGLI, RITAGLI E FRATTAGLIE.
Certe volte mi avanzano degli scarti, che però un po' mi dispiace buttare via, allora ho trovato un sistema per ricciclarli e li metto da qualche parte, ad esempio qui. Il tag a cui li farò corrispondere, questi tagli, ritagli e frattaglie si chiama liBBro.
Un festoso saluto.
sabato 13 giugno 2015
LA TELEFONATA.
Ieri sera al Presidente Sergio Mattarella, sul tardi — era già in pigiama — è arrivata una chiamata. Era sua madre.
Gli ha detto:
Sergio, domani viene da te Quentin Tarantino per via del David di Donatello.
Non è ancora sicuro, mamma — si è difeso subito lui.
Viene, viene. E’ dal ’94 che deve venire, vedrai che viene.
Embè? — ha detto Sergio.
Gli devi dire quella cosa.
Quale cosa, mamma?
Lo sai, quale.
Mamma non cominciamo.
Ti ho già detto di no.
Come, no?
Mamma, è Quentin Tarantino, mica uno qualunque.
Ma che cazzo, tu sei il Presidente della Repubblica Italiana! Un po’ di coraggio! Gli tieni la mano stretta e non lo fai andare via. E intanto glielo dici.
Mamma, perfavore…
Gli dici: Quentin: ti ricordi il ristorante sulla costiera palermitana dove ti sei sposato? Ecco, era il ristorante di mia mamma.
Mamma non lo posso dire.
Devi, dirlo. Vedrai che gli fa piacere.
…e poi durante il cerimoniale non so nemmeno se ci sarà tempo abbastanza.
Cazzate, sei il Presidente della Repubblica. Promettimelo.
Non posso farlo, mamma.
Promettimelo!
Ti ho detto che non posso. E poi sei sicura-sicura che fosse lui?
Certo che sono sicura!
Promesso?
Vedremo.
La telefonata è finita proprio così, con un vedremo. Che c’è da dire che la mamma di Mattarella, quando ci si mette, mmm, è difficile tenergli testa.
Questa mattina al Quirinale il Presidente Sergio Mattarella ha incontrato i candidati al premio David di Donatello, che è il principale premio cinematografico italiano. Il Presidente della Repubblica ogni anno, come da tradizione, in un breve cerimoniale incontra i candidati. Ed è successo che quando è arrivato Quentin Tarantino, Sergio Mattarella, ha preso con una mano la mano di Tarantino, e gliela ha stretta forte. E con l’altra mano ha preso tutto il coraggio che aveva e forse proprio per quello — proprio perché non ha preso il coraggio a due mani ma lo ha preso soltanto con una mano sola — invece che dire quella cosa di sua mamma e del ristorante e del matrimonio e della costiera palermitana, ha detto, con una voce un po’ impastata:
«Uscire dalla crisi non è facile. Signor Tarantino, anche se ci prestasse il suo mister Wolf, non credo che lui da solo riuscirebbe a risolvere tutti i problemi». Un riferimento al film-cult Pulp Fiction.
Tarantino era un po’ in imbarazzo, però si è messo a ridere. Forse è andata anche bene così, ha avuto ragione il Presidente Mattarella a non dirla quella cosa della madre. Che metti che Tarantino non si fosse ricordato del nome del ristorante, della costiera palermitana e magari neanche del suo matrimonio. Che poi: abbiamo controllato se per caso è sposato, Quentin Tarantino?
O metti che — peggio ancora — a Sergio Mattarella fosse venuto in mente quell’altra battuta di Pulp Fiction, quella che fa: “Non è ancora arrivato il momento di farci i pompini a vicenda.”
Ecco, noi voglio dire, noi nel senso di Noi-Popolo-Italiano, che figura ci facevamo?
ps. Nel caso, leggetevi “Momenti di trascurabile felicità”, di Francesco Piccolo, Einaudi. Nel caso, dico.
Gli ha detto:
Sergio, domani viene da te Quentin Tarantino per via del David di Donatello.
Non è ancora sicuro, mamma — si è difeso subito lui.
Viene, viene. E’ dal ’94 che deve venire, vedrai che viene.
Embè? — ha detto Sergio.
Gli devi dire quella cosa.
Quale cosa, mamma?
Lo sai, quale.
Mamma non cominciamo.
Ti ho già detto di no.
Come, no?
Mamma, è Quentin Tarantino, mica uno qualunque.
Ma che cazzo, tu sei il Presidente della Repubblica Italiana! Un po’ di coraggio! Gli tieni la mano stretta e non lo fai andare via. E intanto glielo dici.
Mamma, perfavore…
Gli dici: Quentin: ti ricordi il ristorante sulla costiera palermitana dove ti sei sposato? Ecco, era il ristorante di mia mamma.
Mamma non lo posso dire.
Devi, dirlo. Vedrai che gli fa piacere.
…e poi durante il cerimoniale non so nemmeno se ci sarà tempo abbastanza.
Cazzate, sei il Presidente della Repubblica. Promettimelo.
Non posso farlo, mamma.
Promettimelo!
Ti ho detto che non posso. E poi sei sicura-sicura che fosse lui?
Certo che sono sicura!
Promesso?
Vedremo.
La telefonata è finita proprio così, con un vedremo. Che c’è da dire che la mamma di Mattarella, quando ci si mette, mmm, è difficile tenergli testa.
Questa mattina al Quirinale il Presidente Sergio Mattarella ha incontrato i candidati al premio David di Donatello, che è il principale premio cinematografico italiano. Il Presidente della Repubblica ogni anno, come da tradizione, in un breve cerimoniale incontra i candidati. Ed è successo che quando è arrivato Quentin Tarantino, Sergio Mattarella, ha preso con una mano la mano di Tarantino, e gliela ha stretta forte. E con l’altra mano ha preso tutto il coraggio che aveva e forse proprio per quello — proprio perché non ha preso il coraggio a due mani ma lo ha preso soltanto con una mano sola — invece che dire quella cosa di sua mamma e del ristorante e del matrimonio e della costiera palermitana, ha detto, con una voce un po’ impastata:
«Uscire dalla crisi non è facile. Signor Tarantino, anche se ci prestasse il suo mister Wolf, non credo che lui da solo riuscirebbe a risolvere tutti i problemi». Un riferimento al film-cult Pulp Fiction.
Tarantino era un po’ in imbarazzo, però si è messo a ridere. Forse è andata anche bene così, ha avuto ragione il Presidente Mattarella a non dirla quella cosa della madre. Che metti che Tarantino non si fosse ricordato del nome del ristorante, della costiera palermitana e magari neanche del suo matrimonio. Che poi: abbiamo controllato se per caso è sposato, Quentin Tarantino?
O metti che — peggio ancora — a Sergio Mattarella fosse venuto in mente quell’altra battuta di Pulp Fiction, quella che fa: “Non è ancora arrivato il momento di farci i pompini a vicenda.”
Ecco, noi voglio dire, noi nel senso di Noi-Popolo-Italiano, che figura ci facevamo?
ps. Nel caso, leggetevi “Momenti di trascurabile felicità”, di Francesco Piccolo, Einaudi. Nel caso, dico.
Etichette:
cose,
cosestrane,
medium,
storielline
mercoledì 6 maggio 2015
venerdì 1 maggio 2015
IL MANTELLO DI SUPERMAN.
"Ero nel garage di Walter Bonatti, che da qualche tempo non c’era più. Stavamo cominciando a prenderci cura delle sue cose e del suo archivio personale facendone una sorta di grossolano inventario iniziale. Nel suo garage Rossana aveva radunato delle scatole di cartone che aveva rinvenuto da qualche altra parte, le scatole contenevano dei vecchi numeri di Epoca e dei ritagli di giornale. Secondo Rossana, lì in garage, non c’era probabilmente nient’altro di cui occuparsi. Mi guardai in giro, intorno c’erano degli oggetti di uso comune che si possono rinvenire in qualsiasi garage di qualsiasi casa del mondo. In fondo al garage c’era una tenda tirata che penzolava dal soffitto e che nascondeva il fondo della stanza, chiesi a Rossana là dietro cosa ci potesse essere. Lei ci pensò un attimo e poi mi disse che non c'era niente di particolare, soltanto vecchie cose, non ricordava nemmeno bene. Guardammo. Scostammo la tenda e dietro, in perfetto ordine su uno scaffale, c’erano le scarpe di Walter Bonatti. C’erano scarpe di tutti i tipi: scarponi da montagna usati e meno usati, pesanti e meno pesanti e poi riconobbi tra tutte quelle paia di scarpe, i suoi anfibi. Quelli alti, in pelle, che avevo visto nelle fotografie delle sue avventure in Zaire, In Kongo, in Nuova Guinea, sull’Alto Orinoco. Provo a spiegarvi come mi sentii io, in quel momento. Era come se Superman fosse morto e io, che ero stato chiamato lì nella sua casa a guardare tra le sue cose, mi fossi imbattuto nel suo mantello. Il mantello di Superman. C'era il mantello ripiegato e in ordine dentro a un cassetto, senza più Superman, e poi c’ero io. Voi, come vi sareste sentiti?”
Ieri alla FIERA DEI LIBRAIAngelo Ponta, che è curatore del libro "Walter Bonatti - Giorno per giorno, l’avventura" è venuto a Bergamo all’Auditorium di Piazza della Libertà portando con sé alcune fotografie di Bonatti da proiettare sul grande schermo. Oltre che mostrare queste straordinarie immagini e parlare un po' del libro e della mostra allo Spazio Tadini di Milano (oltre 40.000 presenze), tra le altre cose Angelo ha raccontato questa storiella che a me ha fatto venire la pelle d’oca. Ero seduto sul palco accanto a lui e quando ha finito di dire questa storia avrei voluto avere il coraggio di alzarmi e abbracciarlo e di stringerlo. Tenerlo lì stretto un momento e dirgli grazie, per quello che aveva appena detto e per la cura che si prende dell’Archivio, dentro a cui ha compiuto e continua a compiere una vera e propria esplorazione storica e letteraria. E’ grazie anche al suo lavoro che la memoria di Bonatti viene costruita e protetta. L'archivio di Walter Bonatti è al momento custodito nel caveau di una banca in Valtellina, ci ha detto Angelo. Si tratta di libri, di note, di appunti, quaderni, stampe fotografiche e fotografie digitali che prima che sia troppo tardi, prima che siano deteriorate per sempre, bisognerebbe prendersi la cura di digitalizzare. Ci sono circa 90.000 fotografie. Se fossimo in un paese diverso dall’Italia questo lavoro sarebbe già stato fatto per intero, noi invece siamo ancora quasi fermi alle celebrazioni e ai tagli di nastro una volta ogni tanto e alle querelle legata alla vicenda del K2 o del Freney. Se non ci fosse il lavoro prezioso di persone come Angelo o Alessandro o di altri che conosco e che hanno voluto bene a Bonatti e che continuano a volergliene, il suo patrimonio culturale lasciatoci in eredità andrebbe pian piano perduto. Dimenticato. Peccato che ieri all’Auditorium in Piazza della Libertà, dove eravamo davvero in troppo pochi per la portata dell'evento, non ho visto nessuno dei dirigenti del CAI cittadino. Ogni volta che una manifestazione culturale legata alla montagna, a Bergamo, prova a prendere corpo fuori dalle mura della Casa della Montagna, è quasi sempre così. Ieri forse questa assenza istituzionale che era impossibile non notare era per via del week-end lungo che era appena iniziato. E va beh. O forse era per colpa di qualche riunione di commissione importantissima che non si poteva rimandare. O forse al CAI erano troppo presi con i tortellini del ristorante del Rifugio in città. Peccato però. Per Walter. Per l’alpinismo e per gli appassionati di montagne e di avventura della nostra città. Sarebbe valsa la pena esserci, anche solo per quelle straordinarie foto proiettate sullo schermo gigante e per sentire Angelo raccontare la storia del mantello. Io a un certo punto, quasi quasi, piangevo. -
Foto © Archivio Bonatti - Venezuela, 1967
Ieri alla FIERA DEI LIBRAIAngelo Ponta, che è curatore del libro "Walter Bonatti - Giorno per giorno, l’avventura" è venuto a Bergamo all’Auditorium di Piazza della Libertà portando con sé alcune fotografie di Bonatti da proiettare sul grande schermo. Oltre che mostrare queste straordinarie immagini e parlare un po' del libro e della mostra allo Spazio Tadini di Milano (oltre 40.000 presenze), tra le altre cose Angelo ha raccontato questa storiella che a me ha fatto venire la pelle d’oca. Ero seduto sul palco accanto a lui e quando ha finito di dire questa storia avrei voluto avere il coraggio di alzarmi e abbracciarlo e di stringerlo. Tenerlo lì stretto un momento e dirgli grazie, per quello che aveva appena detto e per la cura che si prende dell’Archivio, dentro a cui ha compiuto e continua a compiere una vera e propria esplorazione storica e letteraria. E’ grazie anche al suo lavoro che la memoria di Bonatti viene costruita e protetta. L'archivio di Walter Bonatti è al momento custodito nel caveau di una banca in Valtellina, ci ha detto Angelo. Si tratta di libri, di note, di appunti, quaderni, stampe fotografiche e fotografie digitali che prima che sia troppo tardi, prima che siano deteriorate per sempre, bisognerebbe prendersi la cura di digitalizzare. Ci sono circa 90.000 fotografie. Se fossimo in un paese diverso dall’Italia questo lavoro sarebbe già stato fatto per intero, noi invece siamo ancora quasi fermi alle celebrazioni e ai tagli di nastro una volta ogni tanto e alle querelle legata alla vicenda del K2 o del Freney. Se non ci fosse il lavoro prezioso di persone come Angelo o Alessandro o di altri che conosco e che hanno voluto bene a Bonatti e che continuano a volergliene, il suo patrimonio culturale lasciatoci in eredità andrebbe pian piano perduto. Dimenticato. Peccato che ieri all’Auditorium in Piazza della Libertà, dove eravamo davvero in troppo pochi per la portata dell'evento, non ho visto nessuno dei dirigenti del CAI cittadino. Ogni volta che una manifestazione culturale legata alla montagna, a Bergamo, prova a prendere corpo fuori dalle mura della Casa della Montagna, è quasi sempre così. Ieri forse questa assenza istituzionale che era impossibile non notare era per via del week-end lungo che era appena iniziato. E va beh. O forse era per colpa di qualche riunione di commissione importantissima che non si poteva rimandare. O forse al CAI erano troppo presi con i tortellini del ristorante del Rifugio in città. Peccato però. Per Walter. Per l’alpinismo e per gli appassionati di montagne e di avventura della nostra città. Sarebbe valsa la pena esserci, anche solo per quelle straordinarie foto proiettate sullo schermo gigante e per sentire Angelo raccontare la storia del mantello. Io a un certo punto, quasi quasi, piangevo. -
Etichette:
alpinismo,
articoli,
cose,
storielline
TUT-TUT-TUT
- Buongiorno, noi siamo una azienda che facciamo delle ricerche e delle statistiche, sono la dottoressa Iccs ( Iccs, si fa per dire) posso farle alcune domande?
- No
- Non è interessato alle nostre ricerche di mercato?
- No
- Posso chiederle che ruolo ricopre nella azienda per cui lavora?
- Terzino sinistro.
- tut-tut-tut-tut...
SIGNIFICATO DELLA PAROLA: CIRCA.
Carta, forbice, sasso.
E va bé.
Papà, auto nuova, bambino, pacchetto-di-Pavesini.
Che è circa lo stesso.
giovedì 16 aprile 2015
GLI HOBBIES, QUANDO PER CASO MUORI.
Io è un po' che non vado in libreria, andare in libreria è uno dei miei hobbies. Hobby con l'acca, aspirata. Hhhhobby. E' importante, bisogna aspirare.
Hobby.
Perfetto.
Gli hobbies sono quella cosa che tutti a quanto pare devono averne uno, è importante avere un hobby (singolare, senza esse finale) perché quando ti fanno la domanda o lo devi scrivere in un curriculum - nei curriculum a quanto pare bisogna sempre scrivere che hobby hai - scrivere modellismo può essere scocciante. Hobby: modellismo. Non ti assumono.
Che poi io tra l'altro non ho niente contro il modellismo e neanche contro i modellisti, ci mancherebbe, anzi. Pensa piuttosto a quelli che scrivono: Hobby: fare shopping. Shopping? Ma veramente? E lo dici in giro? Agghiacciante.
Mai uno che abbia il coraggio di dire la verità e alla voce hobby scriva: mi piace la figa, per dire. Ma non divaghiamo.
A me piace leggere il mio hobby è leggere. E anche scrivere mi piace, ma insomma, quella è una conseguenza. Uno a un certo punto dopo tanto leggere deve provare a scrivere, deve svuotarsi un po', perché scrivere più che a dire delle cose dovrebbe servire per svuotarsi per poi riempirsi di nuovo. Per leggere certi libri bisogna fare spazio ed essere vuoti. Assolutamente vuoti, ci va della preparazione. Ci sono certi personaggi che ci entrano così dentro, certi autori o certe voci sono così forti che l'unico modo per farli uscire dalla nostra testa, per liberarcene, è scrivere. Farli fluire fuori, sulla carta.
Che poi tra parentesi esce fuori un sacco di altra roba quando uno scrive, ed è quello il bello. Leggi un libro, per svuotarti scrivi, e ti vengono fuori delle cose che non c'entrano niente con quello che hai letto e che non sapevi nemmeno di avere dentro.
Comunque. Andare in libreria mi piace, è una specie di appuntamento che ho con una parte di me. Vado lì e mi ritrovo.
- Ciao.
- Ciao.
- Come va?
- Bene dài, e te?
- Bene.
- E' un po' che non mi venivi a trovare.
- Lavoro, famiglia, sport. Scazzi. Stanchezza. Solite cose.
- Capisco. Hai la lista?
- Ce l'ho.
- Grande. Fa vedere.
Tiro fuori la lista dei libri e leggiamo mentalmente, io e me.
Guardiamo i libri che mi sono segnato sulla lista, i libri che vorrei leggere o comperare. Quelli di cui ho sentito parlare oppure di cui ho letto in altri libri. Non è per comprarli, i libri, che uno li compra. E' per averli. Per leggerli certo, ma anche per averli.
Averli lì.
Che se a uno un giorno, tanto tempo dopo, viene voglia di rileggerli, certi libri, meglio averli. Oppure se muore. Se uno muore i suo libri non sono più suoi e i suoi figli o i suoi nipoti o insomma quelli che gli hanno voluto bene, ma anche quelli che non sono riusciti a volergliene perché non erano ancora nati o perché non c'erano ancora, possono farsi una idea di chi era.
Metti che nella libreria hai il libro dei Guinnes dei Primati, quello con la copertina argentata specchiata, ecco, per esempio, uno una idea di chi eri, se la fa. Che poi magari, quel libro lì dei Guinnes dei primati, te l'ha regalata una vecchia zia che non vedi mai per Natale. Un regalo di una zia potrebbe completamente snaturare la tua memoria eterna, ma comunque. Anche le vecchie zie hanno i loro diritti. Anche loro fanno parte della tua storia.
Un mio amico invece, per fare un altro esempio, quando è morto, la sua compagna ha preso tutte le sue magliette e le ha portate in un prato e i suoi amici sono andati tutti in quel prato e ne hanno presa una per uno, quella che volevano e che gli piaceva di più e l'hanno portata via. Adesso se la mettono tutti la maglietta che hanno preso in quel prato quel giorno, la maglia di quel nostro vecchio amico che è morto, una volta ogni tanto se la mettono e la portano in giro e ognuno insomma, a me pare, quel nostro amico lì lo fa sembrare meno morto.
Ecco io ho pensato che si potrebbe fare lo stesso con i libri. Se uno muore, ad esempio, i suoi amici possono prendere i suoi libri, uno per uno. O le sue magliette. O i suoi sci. Mi è venuto in mente che forse a me piace in andare in libreria a comprare dei libri e averli perché se un giorno per caso muoio, io divento le parole che ci sono scritto nei libri che ho letto. Mi piace sciare, mi pare, perché quando scio io sono sono le curve che ho fatto. Mi piace arrampicare perché quando arrampico divento gli appigli che ho stretto.
Eccetera.
Hobby.
Perfetto.
Gli hobbies sono quella cosa che tutti a quanto pare devono averne uno, è importante avere un hobby (singolare, senza esse finale) perché quando ti fanno la domanda o lo devi scrivere in un curriculum - nei curriculum a quanto pare bisogna sempre scrivere che hobby hai - scrivere modellismo può essere scocciante. Hobby: modellismo. Non ti assumono.
Che poi io tra l'altro non ho niente contro il modellismo e neanche contro i modellisti, ci mancherebbe, anzi. Pensa piuttosto a quelli che scrivono: Hobby: fare shopping. Shopping? Ma veramente? E lo dici in giro? Agghiacciante.
Mai uno che abbia il coraggio di dire la verità e alla voce hobby scriva: mi piace la figa, per dire. Ma non divaghiamo.
A me piace leggere il mio hobby è leggere. E anche scrivere mi piace, ma insomma, quella è una conseguenza. Uno a un certo punto dopo tanto leggere deve provare a scrivere, deve svuotarsi un po', perché scrivere più che a dire delle cose dovrebbe servire per svuotarsi per poi riempirsi di nuovo. Per leggere certi libri bisogna fare spazio ed essere vuoti. Assolutamente vuoti, ci va della preparazione. Ci sono certi personaggi che ci entrano così dentro, certi autori o certe voci sono così forti che l'unico modo per farli uscire dalla nostra testa, per liberarcene, è scrivere. Farli fluire fuori, sulla carta.
Che poi tra parentesi esce fuori un sacco di altra roba quando uno scrive, ed è quello il bello. Leggi un libro, per svuotarti scrivi, e ti vengono fuori delle cose che non c'entrano niente con quello che hai letto e che non sapevi nemmeno di avere dentro.
Comunque. Andare in libreria mi piace, è una specie di appuntamento che ho con una parte di me. Vado lì e mi ritrovo.
- Ciao.
- Ciao.
- Come va?
- Bene dài, e te?
- Bene.
- E' un po' che non mi venivi a trovare.
- Lavoro, famiglia, sport. Scazzi. Stanchezza. Solite cose.
- Capisco. Hai la lista?
- Ce l'ho.
- Grande. Fa vedere.
Tiro fuori la lista dei libri e leggiamo mentalmente, io e me.
Guardiamo i libri che mi sono segnato sulla lista, i libri che vorrei leggere o comperare. Quelli di cui ho sentito parlare oppure di cui ho letto in altri libri. Non è per comprarli, i libri, che uno li compra. E' per averli. Per leggerli certo, ma anche per averli.
Averli lì.
Che se a uno un giorno, tanto tempo dopo, viene voglia di rileggerli, certi libri, meglio averli. Oppure se muore. Se uno muore i suo libri non sono più suoi e i suoi figli o i suoi nipoti o insomma quelli che gli hanno voluto bene, ma anche quelli che non sono riusciti a volergliene perché non erano ancora nati o perché non c'erano ancora, possono farsi una idea di chi era.
Metti che nella libreria hai il libro dei Guinnes dei Primati, quello con la copertina argentata specchiata, ecco, per esempio, uno una idea di chi eri, se la fa. Che poi magari, quel libro lì dei Guinnes dei primati, te l'ha regalata una vecchia zia che non vedi mai per Natale. Un regalo di una zia potrebbe completamente snaturare la tua memoria eterna, ma comunque. Anche le vecchie zie hanno i loro diritti. Anche loro fanno parte della tua storia.
Un mio amico invece, per fare un altro esempio, quando è morto, la sua compagna ha preso tutte le sue magliette e le ha portate in un prato e i suoi amici sono andati tutti in quel prato e ne hanno presa una per uno, quella che volevano e che gli piaceva di più e l'hanno portata via. Adesso se la mettono tutti la maglietta che hanno preso in quel prato quel giorno, la maglia di quel nostro vecchio amico che è morto, una volta ogni tanto se la mettono e la portano in giro e ognuno insomma, a me pare, quel nostro amico lì lo fa sembrare meno morto.
Ecco io ho pensato che si potrebbe fare lo stesso con i libri. Se uno muore, ad esempio, i suoi amici possono prendere i suoi libri, uno per uno. O le sue magliette. O i suoi sci. Mi è venuto in mente che forse a me piace in andare in libreria a comprare dei libri e averli perché se un giorno per caso muoio, io divento le parole che ci sono scritto nei libri che ho letto. Mi piace sciare, mi pare, perché quando scio io sono sono le curve che ho fatto. Mi piace arrampicare perché quando arrampico divento gli appigli che ho stretto.
Eccetera.
lunedì 23 marzo 2015
IL PIANTAGRANE.
Quando ero piccolo pensavo che il "piantagrane" fosse un attrezzo. Una specie di piccola trivella cicciotta e filettata, lunga una ventina di centimetri con una impugnatura verde (non so perché ma io l'impugnatura me la immaginavo verde). La trivella aveva grossomodo la forma e le proporzioni di un cono gelato capovolto, leggermente più grande di un cono gelato però molto più robusta, in metallo, con delle alette filettate e taglienti e con questa impugnatura ovale che riempiva il palmo di una mano.
Non riuscivo a immaginare tecnicamente il funzionamento esatto della “piantagrane" ma immaginavo che fosse necessario appoggiarla per terra, fare pressione sull’impugnatura caricandoci bene sopra tutto il peso del corpo, e poi lasciarla lavorare. Poi faceva tutto lei. Se qualcuno mi avesse chiesto se ne avevo mai vista una di trivella piantagrane avrei quasi certamente risposto di sì, che l'avevo vista, tanto ero convinto. Ero sicuro di averne vista una tra gli attrezzi da lavoro di mio nonno.
Poi diventando grande capii senza che nessuno me lo spiegasse che per "piantagrane" non si intende un attrezzo ma si intendono dei soggetti, delle persone, una certo tipo specifico di persone. Persone piuttosto pignole e rognose con cui avere a che fare, diciamo. E' un modo di dire.
Una volta un po' di tempo fa ero in fila per fare un documento in un ufficio comunale, eravamo in fila nel corridoio e c’era lì un signore che pareva saperla lunga di documenti e di file e di uffici comunali e che aveva iniziato a puntarmi e a parlarmi e che a un certo punto di un discorso che io non capivo nemmeno molto bene se devo dire la verità, aveva buttato lì la parola “piantagrane”. Che io effettivamente erano dei secoli che non la sentivo dire, la parola “piantagrane". Pianta da pianta, grane da grane. Piantare-grane. Mi era subito venuta in mente tutta questa storia di quando ero bambino e la forma esatta dello strumento “piantagrane”, mi erano venute perfino in mente le alette filettate e la forma e il colore dell’impugnatura. Ovale, verde. Il signore che mi parlava e che mi incalzava nel discorso mi veniva sempre più vicino inclinandosi verso di me con la testa e sollevandosi sulla punta dei piedi, usava un tono sempre più polemico e confidenziale, lanciando delle occhiate ostili a destra e a sinistra verso le altre persone in fila nel corridoio e verso gli impiegati che ogni tanto passavano di lì. Il signore si doveva anche essere accorto del mio ascolto distratto e piuttosto superficiale, intanto. Doveva avere notato il mio sguardo fisso nel vuoto in un punto indefinito in fondo al corridoio e il fatto che io stavo pensando quasi certamente ai cazzi miei.
Indossava un cappotto color cammello elegante e teneva una cartellina porta documenti nelle mani che si passava continuamente dalla destra alla sinistra, e dalla sinistra alla destra, nervosamente. Era ben pettinato e rasato e aveva un profumo deciso di dopobarba alla menta. Si avvicinava e allontanava da a me continuamente con una sequenza ininterrotta di mezzi passi e giravolte, aveva ai piedi dei mocassini neri un po’ lisi, si capiva che ci doveva avere camminato dentro parecchio. A un certo punto, all’improvviso, dopo qualche secondo di sospensione del discorso, prese a fissarmi dritto negli occhi, mi venne vicinissimo per parlare, deviando all’ultimo istante in direzione dell’orecchio sinistro. Io feci docilmente il gesto di girare un po’ la testa di lato, per agevolarlo, non sapevo che altro potevo fare. Girai la testa leggermente di lato e rimasi in silenzio ad ascoltare.
Il signore diede una ultima occhiata furtiva a destra e a sinistra per assicurarsi che nessuno delle persone in attesa nel corridoio ci potesse sentire, in fila c’erano parecchie altre persone che ci osservavano tutte. Iniziò a sussurrare una frase a bassa voce che all’inizio non capii, capii solo che il soggetto del discorso era responsabile dell’ufficio dove stavamo per consegnare il documento. “Lei lo sa cosa è un piantagrane?” feci cenno di sì con la testa muovendola avanti e indietro, per fare intendere che avevo capito, poi mi fermai rimanendo immobile in attesa del resto del discorso. “Lei lo sa cosa vuole dire avere una trivella puntata direttamente sui coglioni?”.
Sbarrai gli occhi. Il piantagrane - pensai - lo strumento: quindi, esiste per davvero?
Non riuscivo a immaginare tecnicamente il funzionamento esatto della “piantagrane" ma immaginavo che fosse necessario appoggiarla per terra, fare pressione sull’impugnatura caricandoci bene sopra tutto il peso del corpo, e poi lasciarla lavorare. Poi faceva tutto lei. Se qualcuno mi avesse chiesto se ne avevo mai vista una di trivella piantagrane avrei quasi certamente risposto di sì, che l'avevo vista, tanto ero convinto. Ero sicuro di averne vista una tra gli attrezzi da lavoro di mio nonno.
Poi diventando grande capii senza che nessuno me lo spiegasse che per "piantagrane" non si intende un attrezzo ma si intendono dei soggetti, delle persone, una certo tipo specifico di persone. Persone piuttosto pignole e rognose con cui avere a che fare, diciamo. E' un modo di dire.
Una volta un po' di tempo fa ero in fila per fare un documento in un ufficio comunale, eravamo in fila nel corridoio e c’era lì un signore che pareva saperla lunga di documenti e di file e di uffici comunali e che aveva iniziato a puntarmi e a parlarmi e che a un certo punto di un discorso che io non capivo nemmeno molto bene se devo dire la verità, aveva buttato lì la parola “piantagrane”. Che io effettivamente erano dei secoli che non la sentivo dire, la parola “piantagrane". Pianta da pianta, grane da grane. Piantare-grane. Mi era subito venuta in mente tutta questa storia di quando ero bambino e la forma esatta dello strumento “piantagrane”, mi erano venute perfino in mente le alette filettate e la forma e il colore dell’impugnatura. Ovale, verde. Il signore che mi parlava e che mi incalzava nel discorso mi veniva sempre più vicino inclinandosi verso di me con la testa e sollevandosi sulla punta dei piedi, usava un tono sempre più polemico e confidenziale, lanciando delle occhiate ostili a destra e a sinistra verso le altre persone in fila nel corridoio e verso gli impiegati che ogni tanto passavano di lì. Il signore si doveva anche essere accorto del mio ascolto distratto e piuttosto superficiale, intanto. Doveva avere notato il mio sguardo fisso nel vuoto in un punto indefinito in fondo al corridoio e il fatto che io stavo pensando quasi certamente ai cazzi miei.
Indossava un cappotto color cammello elegante e teneva una cartellina porta documenti nelle mani che si passava continuamente dalla destra alla sinistra, e dalla sinistra alla destra, nervosamente. Era ben pettinato e rasato e aveva un profumo deciso di dopobarba alla menta. Si avvicinava e allontanava da a me continuamente con una sequenza ininterrotta di mezzi passi e giravolte, aveva ai piedi dei mocassini neri un po’ lisi, si capiva che ci doveva avere camminato dentro parecchio. A un certo punto, all’improvviso, dopo qualche secondo di sospensione del discorso, prese a fissarmi dritto negli occhi, mi venne vicinissimo per parlare, deviando all’ultimo istante in direzione dell’orecchio sinistro. Io feci docilmente il gesto di girare un po’ la testa di lato, per agevolarlo, non sapevo che altro potevo fare. Girai la testa leggermente di lato e rimasi in silenzio ad ascoltare.
Il signore diede una ultima occhiata furtiva a destra e a sinistra per assicurarsi che nessuno delle persone in attesa nel corridoio ci potesse sentire, in fila c’erano parecchie altre persone che ci osservavano tutte. Iniziò a sussurrare una frase a bassa voce che all’inizio non capii, capii solo che il soggetto del discorso era responsabile dell’ufficio dove stavamo per consegnare il documento. “Lei lo sa cosa è un piantagrane?” feci cenno di sì con la testa muovendola avanti e indietro, per fare intendere che avevo capito, poi mi fermai rimanendo immobile in attesa del resto del discorso. “Lei lo sa cosa vuole dire avere una trivella puntata direttamente sui coglioni?”.
Sbarrai gli occhi. Il piantagrane - pensai - lo strumento: quindi, esiste per davvero?
lunedì 16 marzo 2015
ON NE MARCHE QU'UNE FOIS SUR LA LUNE.
Ciascuno di noi nel proprio intimo, sa di avere camminato almeno una volta sulla Luna. Chi non lo ha ancora fatto prima o poi lo farà o almeno questo è quello che bisogna augurarsi, questa è la speranza. Andare più in là, oltre, lasciandosi tutto alle spalle per cercare un senso, per dare valore ad una vita intera. Non sempre la nostra esperienza personale verrà condivisa, non necessariamente si tratterà di qualcosa di estremo o di eccitante, di grandioso, di interessante, non sempre gli altri capiranno o sapranno, di noi e di quel momento in cui la nostra vita e le nostre certezze sono state in bilico e il nostro destino si è probabilmente compiuto. Abbiamo mollato i freni e siamo andati. Via. In un luogo che non è un luogo ma è piuttosto uno stato della mente. Al nostro ritorno, dopo quella volta, non eravamo più gli stessi di prima.
E' probabilmente in questo punto di contatto con la normalità, con la vita quotidiana di ciascuno di noi il senso profondo ed universale dell'alpinismo, sempre che l'alpinismo un senso ce l'abbia: lo scopo dell' alpinismo non è conquistare ma casomai esplorare. Indagare le possibilità. Più che dare risposte l'alpinismo si occupa delle domande, si occupa di accoglierle. Non si tratta di tramutare l'impossibile in possibile come sostengono alcuni, quanto di accettare l'idea dell'incognito come una possibilità ed andargli incontro, consapevolmente. Si tratta di una ricerca infinita che a volte richiede lo sforzo di andare fin sulla Luna e altre volte, no. A volte basta guardarsi intorno e provare con coraggio, nel nostro piccolo, a cambiare. Fare un passo in una direzione diversa. Insistere e perseverare. Non voltarsi mai indietro, mai.
Il resto poi, vien da sé.
E' probabilmente in questo punto di contatto con la normalità, con la vita quotidiana di ciascuno di noi il senso profondo ed universale dell'alpinismo, sempre che l'alpinismo un senso ce l'abbia: lo scopo dell' alpinismo non è conquistare ma casomai esplorare. Indagare le possibilità. Più che dare risposte l'alpinismo si occupa delle domande, si occupa di accoglierle. Non si tratta di tramutare l'impossibile in possibile come sostengono alcuni, quanto di accettare l'idea dell'incognito come una possibilità ed andargli incontro, consapevolmente. Si tratta di una ricerca infinita che a volte richiede lo sforzo di andare fin sulla Luna e altre volte, no. A volte basta guardarsi intorno e provare con coraggio, nel nostro piccolo, a cambiare. Fare un passo in una direzione diversa. Insistere e perseverare. Non voltarsi mai indietro, mai.
Il resto poi, vien da sé.
On ne marche qu'une fois sur la lune - La bande annonce from Editions Guérin on Vimeo.
Etichette:
alpinismo,
cose,
recensioni,
video
sabato 14 marzo 2015
DOVE VA A FINIRE IL TELEMARK?
Il testo ufficiale FISI del telemark è dell'anno 2000. L'ultimo Master Istruttori FISI è del 2006. Io sono maestro di telemark dal 2006 e non so prima ma da allora fino a oggi - sono passati quasi dieci anni - non è mai stato organizzato un aggiornamento tecnico, a cui decine o forse qualche centinaio di maestri specializzati me compreso parteciperebbero volentieri, a pagamento s'intende.
Per quanto io sia amico di molti istruttori e li stimi singolarmente come individui, come telemarker e come maestri, in dieci anni non ho mai visto prodotto da parte del gruppo Istruttori un singolo foglio di carta, un .pdf, una newsletter digitale o un video insomma qualcosa utile a migliorare la mia capacità di insegnante o quantomeno di semplice appassionato.
Gli Istruttori Nazionali di Telemark non hanno un sito web ufficiale, non hanno una pagina Facebook (non una ufficiale che venga aggiornata con regolarità), nel sito FISI.org degli Istruttori di telemark e della loro attività non c'è la minima traccia e agli ultimi due Interski della Korea (dove ho partecipato come snowboarder) e dell'Austria il telemark italiano non è stato rappresentato. L'attività giovanile ed agonistica federale italiana è pressoché inesistente e la figura dell'allenatore di telemark ancora deve venire. Un dove condividere con continuità i contenuti tecnici che gli Istruttori Nazionali in quanto tali producono - mi chiedo se effettivamente ne producono, di contenuti? - non c'è.
Voglio dire: gli Istruttori Nazionali - escluse le "quasi-sempre" ammirevoli iniziative dei singoli - non comunicano e non condividono, non in modo ufficiale e non con una voce univoca. Aggiungo che i modi in cui gli istruttori si propongono contemporaneamente sia al libero mercato che ai professionisti è quantomeno ambiguo. Forse è ora di decidere se gli Istruttori Nazionali FISI vogliono fare i tecnici cioè gli Istruttori per davvero o se vogliono continuare ad accontentarsi di essere delle specie di super-Maestri nel libero mercato.
All'InterTele o all'Interski, secondo me, gli Istruttori Nazionali è la FISI che ce li deve mandare, non noi.
Noi - mi chiedo se esiste un noi telemark italiano a questo punto?- mandiamoci tre in gamba, tre che hanno voglia di mettersi in gioco e stare a sentire cosa succede in altri paesi del mondo per poi tornare e condividere, raccontandoci cosa si è detto. Se poi questi tre che si decide di mandare sono anche istruttori nazionali di telemark va benissimo, ma se ci andranno non è con la patacca da istruttore e in nome della FISI che devono sciare.
Perlomeno, questo è quello che penso io, che se ci riesco, con i miei soldi e da libero telemarker, all'InterTele ho intenzione di andarci. Per gli altri tre qui c'è un link al progetto di crowdfunding con cui potete inviare il vostro contributo.
Se amate il telemark, un piccolo contributo, potreste versarlo. E se lo fate, grazie.
Per quanto io sia amico di molti istruttori e li stimi singolarmente come individui, come telemarker e come maestri, in dieci anni non ho mai visto prodotto da parte del gruppo Istruttori un singolo foglio di carta, un .pdf, una newsletter digitale o un video insomma qualcosa utile a migliorare la mia capacità di insegnante o quantomeno di semplice appassionato.
Gli Istruttori Nazionali di Telemark non hanno un sito web ufficiale, non hanno una pagina Facebook (non una ufficiale che venga aggiornata con regolarità), nel sito FISI.org degli Istruttori di telemark e della loro attività non c'è la minima traccia e agli ultimi due Interski della Korea (dove ho partecipato come snowboarder) e dell'Austria il telemark italiano non è stato rappresentato. L'attività giovanile ed agonistica federale italiana è pressoché inesistente e la figura dell'allenatore di telemark ancora deve venire. Un dove condividere con continuità i contenuti tecnici che gli Istruttori Nazionali in quanto tali producono - mi chiedo se effettivamente ne producono, di contenuti? - non c'è.
Voglio dire: gli Istruttori Nazionali - escluse le "quasi-sempre" ammirevoli iniziative dei singoli - non comunicano e non condividono, non in modo ufficiale e non con una voce univoca. Aggiungo che i modi in cui gli istruttori si propongono contemporaneamente sia al libero mercato che ai professionisti è quantomeno ambiguo. Forse è ora di decidere se gli Istruttori Nazionali FISI vogliono fare i tecnici cioè gli Istruttori per davvero o se vogliono continuare ad accontentarsi di essere delle specie di super-Maestri nel libero mercato.
All'InterTele o all'Interski, secondo me, gli Istruttori Nazionali è la FISI che ce li deve mandare, non noi.
Noi - mi chiedo se esiste un noi telemark italiano a questo punto?- mandiamoci tre in gamba, tre che hanno voglia di mettersi in gioco e stare a sentire cosa succede in altri paesi del mondo per poi tornare e condividere, raccontandoci cosa si è detto. Se poi questi tre che si decide di mandare sono anche istruttori nazionali di telemark va benissimo, ma se ci andranno non è con la patacca da istruttore e in nome della FISI che devono sciare.
Perlomeno, questo è quello che penso io, che se ci riesco, con i miei soldi e da libero telemarker, all'InterTele ho intenzione di andarci. Per gli altri tre qui c'è un link al progetto di crowdfunding con cui potete inviare il vostro contributo.
Se amate il telemark, un piccolo contributo, potreste versarlo. E se lo fate, grazie.
Etichette:
freeriding,
officina,
telemark
lunedì 2 marzo 2015
COMBATTERE.
“Per fare questo mestiere bisogna combattere, perché nessuno ti chiede di produrre un’opera.”
- Yuri Ancarani
E' vero, per fare questo mestiere bisogna combattere.
E certe volte si perde.
Io, per ora, a quanto pare, ho perso.
E' vero, per fare questo mestiere bisogna combattere.
E certe volte si perde.
Io, per ora, a quanto pare, ho perso.
sabato 17 gennaio 2015
JEAN AFASSANIEFF FUMAVA LE GITANES BLU.
Jean Afanassieff aveva un nome che sembrava finto. Leggerlo e ricordarlo esattamente quel nome, scriverlo correttamente, era già un impresa. Una avventura. Era più facile ricordarsi dei suoi capelli lunghissimi, castani, lisci. Negli anni ’80 avere i capelli lunghi per essere un climber o un alpinista — un certo tipo di climber e di alpinista — era indispensabile o almeno così mi pareva. Io negli anni ’80 ho avuto tra i tredici e i ventitré anni, gli anni più belli della vita, quelli in cui diventi quello che poi sarai per sempre. Edlinger aveva i capelli lunghi. Berahult, aveva i capelli lunghi. Reinhold Messner aveva i capelli lunghi e ce li avevano i britannici Doug Scott, Chris Bonington, Peter Boardman. Jean Marc Boivin, il mio idolo assoluto, aveva i capelli lunghi. Tutti quelli a cui avrei voluto somigliare avevano i capelli lunghi e un po’ in disordine. Allora anche io mi ero fatto crescere i capelli lunghi. Compatibilmente con mia madre, li tenevo abbastanza in disordine. Jean Afanassieff però era diverso. Intanto aveva dei capelli lunghissimi, più lunghi di tutti gli altri, quasi da donna, curati e poi aveva quel nome che sembrava finto. Afanassieff. Sembrava che nello scriverlo ci fosse stato un refuso o un errore, nessuno sembrava ricordarlo davvero quel nome, ma io avevo imparato a riconoscerlo sulle riviste di alpinismo e a tenerlo a mente. Era così affascinante quel rincorrersi di consonanti e di vocali. A-fana-ssieff, in fondo non era difficile da memorizzare. Sapevo che quando mi imbattevo in quel nome ci sarebbe sempre stata sempre la certezza di venire a sapere qualcosa di straordinario, di innovativo, di rivoluzionario dal punto di vista alpinistico. Jean Afanassieff si è fatto conoscere con una serie lunghissima di salite solitarie in velocità nel massiccio del Monte Bianco, salite che poi nel tempo, seguendo le sue tracce, sarei andato a vedere o a ripetere così come si va a visitare un tempio, un luogo in cui si sente la necessità di essere mettendosi al cospetto di qualcun altro, alla ricerca di se stessi. L’ intero inverno del 1977 Afanassieff lo trascorse sciando a Bugaboos, in Canada (un altro luogo che in seguito sarei andato a conoscere) e nel 1978 fu il primo francese in vetta all’Everest, in autunno, insieme a Nicolas Jaeger e Kurt Diemberger. La sua fu la 72esima salita della montagna. Nicolas Jaeger fu un’altro personaggio fondamentale nel mio diventare uomo. Alpinista e fisiologo contribuì in modo determinante a conoscere i meccanismi dell’adattamento dell’essere umano all’alta quota, trascorse sessanta giorni a 6768 metri in vetta all’Huascaran, tempo in cui scrisse un libro che si intitola “ Carnet de solitude”, “Solitudine” nell’edizione italiana. Bellissimo. Giunto in vetta all’Everest Jaeger si accese e fumò una Gitanes, le stesse sigarette che fumava anche Edlinger. Se mai avessi iniziato a fumare un giorno, avrei fumato delle Gitanes, ma non divaghiamo adesso. Afassanieff: insieme alla prima salita francese dell’Everest compì nello stesso giorno anche la prima discesa di un 8000 con gli sci, partendo da quota 8300. Un exploit assoluto, non soltanto per l’epoca. Infischiandosene delle collezioni di 8000 Afassanieff tornò in seguito altre tre volte all’Everest, per il versante Nord. Nel 1979 fu escluso dalla spedizione nazionale alla Magic Line del K2, accadde per via di alcune dichiarazioni scomode dopo la spedizione nazionale dell’anno prima e per via del suo carattere piuttosto naïf, Afassanieff non mandava certo a dire quello che pensava. Restare escluso da una spedizione perché hai detto quello che pensi. Dire quello che pensi sempre, anche se non conviene. Anche se ti tagliano fuori. A me sembrava grandioso, anzi è grandioso, lo penso tuttora. Una cosa di cui andare orgogliosi, non è importante se nel frattempo ti perdi qualcosa. In seguito Afassanieff sarebbe diventato un documentarista o come si dice oggi, un filmmacker. Uno che si prende cura di raccogliere e di raccontare delle storie. “Certi mi considerano un alpinista, certi un regista, mi rendo conto di essere un personaggio complicato, difficile da inquadrare. Io sono stato alpinista e sciatore in una vita precedente e oggi, nella mia nuova vita, anche se ancora pratico l’arrampicata e lo sci per piacere personale, mi considero un autore. Il mio mestiere e la mia passione è quella di raccontare delle storie attraverso i miei film”. Jean Afassanieff se n’è andato qualche giorno fa, a 61 anni per un male incurabile. Non ho mai avuto la fortuna di incontrarlo di persona ma la sua storia, la sua vita, mi hanno sempre ispirato. Se penso a uno a cui avrei voluto assomigliare, uno che mi ha fatto sognare, uno di cui vorrei ricalcare la traccia, parlo come alpinista e come sciatore ma anche come autore, come appassionato di storie da raccontare, penso a lui, a Jean Afanassieff. Buon viaggio, Maestro. Adieu.
Etichette:
alpinismo,
articoli,
climbing,
filmfestival,
nanga parbat,
ski,
storytelling
venerdì 2 gennaio 2015
C'ERANO UNA VOLTA LE CHIACCHIERE IN SEGGIOVIA.
C'erano una volta le chiacchiere in seggiovia. Si scivolava in avanti sugli sci allineati e ci si dava uno sguardo, poi tutti seduti e attenzione alla sbarra. Posso? Prego. Attenzione alla testa. Vada - e tiravi giù e tutti si sistemavano sul poggiapiedi, certi si accendevano perfino una bella sigaretta. Belle le piste oggi, vero? Proprio, giornata fantastica. Senta, volevo chiederle: una informazione. Dica? Qui come sono le piste? è la prima volta che vengo. E tu cercavi di spiegare e spiegavi, parlavi delle piste e dei ristoranti, davi un nome alle montagne intorno arrivando circa al pilone 8 poi finiva che chiedevi al tuo interlocutore da dove venisse lui, e lui ti rispondeva - mettiamo - da Voghera. Tu gli dicevi che avevi avuto una morosa di Voghera o magari che durante il militare avevi conosciuto uno di Voghera - Però adesso non mi ricordo il nome - facevi lo sforzo di ricordare e ricordavi che lui era alto e magro oppure basso e grasso, che era biondo o moro o calvo e che la sua famiglia aveva una farmacia - o una panetteria o un negozio di casalinghi, é lo stesso, lo dico per fare degli esempi - e il tuo interlocutore di Voghera o di Mantova o di Forlì verso il pilone 12 faceva uno sforzo per ricordare e per capire chi potesse essere esattamente il tuo commilitone e saltava fuori che lo conosceva e che quella che ricordavi come una farmacia era in realtà una gastronomia che però adesso non c'è più e che il tuo amico si chiamava Mario Rossi - diceva lui, il tipo in seggiovia - mentre nella tua mente invece, all'improvviso, compariva nitido e inequivocabile un nome che non era Mario, ma Fabrizio. E un cognome che era Rossi. Fabrizio Rossi, classe 67. Ti era venuto in mente il nome esatto. Ah, sì, è il fratello di Mario - ti diceva il tipo e intanto eri arrivato alla stazione a monte, scendevi dalla seggiovia e salutavi i tuoi compagni di viaggio e gli dicevi Salutatemi Fabrizio se lo vedete e loro Senz'Altro! E andavano via. Stavi lì in piedi a guadrarti intorno, dopo esserti stretto gli scarponi, é ripetevi mentalmente il nome Fabrizio Rossi, che eri andato a ripescare nei meandri della tua memoria chissà dove. Una volta tutto questo poteva succedere. Una volta. Adesso ci sono gli smartphone.
venerdì 26 dicembre 2014
NATALE
Il Natale è la capacità di vedere la bellezza dentro agli altri che hai intorno. È la capacità di desiderare e di attendere, di vedere questa bellezza che nasce e che cresce ed esserne parte. C'è chi questa bellezza riesce a vederla ogni giorno, ovunque, dentro ogni cosa e dentro a chiunque, conservando la capacità di sorprendersi e di sorprendere e questo è ciò che significa fare della propria vita Natale: significa venire al mondo, ogni giorno. Riuscire ad essere quello che vuoi. Che è la più bella cosa che si può augurare a chiunque: di esistere, pienamente.
mercoledì 17 dicembre 2014
SCIARE SOTTO AL NANGA PARBAT.
La spedizione era finita e avevamo cominciato il viaggio di ritorno. Quando le spedizioni finiscono c'è una voglia pazzesca i ritornare a casa, ti assale una specie di frenesia, una accelerazione del desiderio di essere a casa propria, con le persone care, che è difficile da controllare. Alla mattina avevamo smontato le tende e preparato tutto, i portatori avevano suddiviso i carichi e caricato i muli e avevamo iniziato la discesa dal campo base del Nanga Parbat verso Rupal, che è il primo piccolo villaggio a qualche ora di cammino. Alla euforia mia e di Simone e di David mi sembrava che corrispondesse una malinconia dei ragazzi pakistani che erano stati con noi. Sapevano che difficilmente ci saremmo rivisti.
Di tanto in tanto durante la spedizione qualche ragazzo saliva dal villaggio per portare qualcosa, dei rifornimenti, qualche ortaggio o per avere qualche medicinale dei nostri per curare la tosse o l'influenza o semplicemente per farci visita. Un giorno uno di loro, Jamil, era salito con un paio di vecchi sci da fondo per sciare con me. Avevamo speso il pomeriggio a parlare e a girare in tondo su un anello improvvisato sul grande piano di Lattaboo, dove stava il nostro campo. Jamil mi aveva spiegato che quegli sci appartenevano a suo fratello che faceva parte delle troupe speciali dell'esercito pakistano, se li era fatti prestare ed era salito appositamente per sciare con me. Era stato un bel giorno.
Quando iniziammo il cammino di discesa per andare via, dopo le foto di rito con i polacchi che sarebbero rimasti un altro po' per recuperare i loro materiali sparsi sulla montagna, mi accorsi che un gran numero di bambini erano saliti con i genitori o con i fratelli o con gli zii per aiutare nel trasporto a valle dei nostri materiali. Questi bambini mi giravano intorno, curiosi, facendomi tutti la stessa domanda. Gli sci? Dove sono i tuoi sci? Non li vedevano. Dissi che erano nella sacca lunga, quella azzurra e che da qualche parte c'erano gli scarponi, i bastoncini li avevo in mano, li avrei usati per camminare in discesa. Non capivo bene tutto questo interesse dei bambini per i miei sci ma poi, mentre camminavo verso valle mi resi conto che nella desolazione e nella normalità di un luogo come quello, dove l'unica attrattiva fuori dall'ordinario è rappresentata da qualche alpinista occidentale o trekker che può capitare di vedere durante l'estate, io rappresentavo una eccezione. Una specie di alpinista Superman. Io per quei bambini ero uno sciatore, quello che aveva sciato sul Nanga Parbat, non un normale alpinista. Era diverso. Per loro era di più.
Sul sentiero di ritorno davanti a me e dietro a un mulo che ci precedeva un ragazzino che avrà avuto sui quindici anni camminava con uno zainetto sulle spalle e nelle mani teneva due delle cose più scomode che la mia mente possa immaginare da maneggiare e trasportare: una thermos arancione da cinque litri (vuota) e un grosso rotolo di gommapiuma espansa, quella che avevamo usato come isolante sul pavimento della nostra tenda casa. Era un cilindro altro due metri e del diametro di una cinquantina di centimetri tenuto insieme da uno spago, era leggerissimo ma ingombrante e scomodo da maneggiare. Il ragazzino aveva ai piedi un paio di stivali di gomma e procedeva senza lamentarsi con un passo che alternava continuamente tra veloce e lentissimo. Riconobbi lo zainetto che teneva in spalla che era quello che conteneva il computer di Simone, non era né ingombrante né pesante, ma molto delicato, gli era stato affidato per averne particolare cura. A un certo punto, prima di un tratto in salita, dissi a quel ragazzino di darmi o la thermos o il rotolone di gomma piuma, che lo avrei aiutato trasportandolo io. Mi disse di no e si guardò in giro nella speranza che nessuno dei grandi ci avesse sentito. Insistetti un po' perché non mi andava di vedere un ragazzino che poteva avere l'età di mio figlio camminare così scomodo, non erano carichi pesanti, ma erano scomodi da trasportare. Lui non volle.
Dopo un po' mentre la nostra carovana procedeva e camminavamo mi si avvicinò un uomo che era uno zio del ragazzo, non parlava inglese, ma mi fece un gesto con gli occhi per riferirsi al nipote e uno con la mano che avrebbe potuto sembrare "piano", mimava quel gesto con la mano di rallentare, ma che capii che invece si riferiva al ragazzino davanti a noi e che significava "ci vuole pazienza, tu stai tranquillo, non preoccuparti. Lascialo fare." Con i gesti, con lo sguardo e con un unica parola inglese mi fece capire che in tutto questo, nella scelta di assegnare a quel ragazzo quel carico, al tempo stesso leggero e molto scomodo da trasportare, c'era un progetto educativo ben preciso. L'uomo, che avrà avuto la mia età ma che sembrava molto più vecchio mi disse: "learning". Imparare. La parola gli usci a fatica dalla bocca facendosi spazio tra dei denti radi e bianchissimi. Capii perfettamente e annuii. Il ragazzo stava imparando, e così tutti gli altri.
Scendemmo ancora, nevicava intanto, Simone e David scesero a valle quasi di corsa, io restai indietro con i portatori a fare qualche foto e a filmare. Quando fummo a Rupal, dopo qualche ora, individuai nel centro del villaggio la casa di Aquil, ci eravamo già passati a dicembre, in salita, ma ora c'era molta più neve. Fuori di casa su un filo c'era qualche panno steso, tutto intorno a delimitare quelli che d'estate devono essere orti c'erano delle staccionate fatte di rametti secchi e sottili che si sfrangiavano puntando verso l'alto. Una vivace colonna di fumo saliva dal comignolo della casa di Aquil, nella quale era stato preparato un pranzo speciale per noi, mentre nelle altre case vicine, dai comignoli, usciva solo un leggerissimo alito di fumo. Faceva un freddo cane, ma era molto meno freddo che a Lattaboo. Arrivai fuori dalla casa di Aquil e c'erano tutti i bambini del paese ad aspettarmi, in piedi con le mani in tasca. Mi guardavano.
Uno di loro, il più grande, aveva un paio di sci Dynastar ai piedi recuperati chissà dove e un paio di scarponi Nordica a calzata posteriore. I bambini mi chiesero ancora una volta tutti insieme dove erano i miei sci perché volevano che io sciassi con loro, solo che a quel punto la mia sacca con gli sci e gli scarponi doveva aver proseguito verso valle in groppa a un mulo. La delusione fu grande e capii che non potevo cavarmela così. I bambini mi aspettavano da due mesi e mezzo e mi guardavano e si aspettavano qualcosa di speciale da me, così invece che entrare a mangiare dove gli altri mi aspettavano, dissi: "Let's go skiing". Ci fu un immediato animarsi del gruppo e un vociare in una lingua a me incomprensibile e tutti corsero in discesa verso il campetto di neve che c'era appena più in basso. Il ragazzo grande con gli sci prese i bastoncini e iniziò a spingersi e a scendere, pattinando verso valle. In fondo al pendio fece una curva verso sinistra e poi risalì di corsa e fece un altro giro e poi un altro e un altro. I bambini mi guardavano, come per sapere se avevo un giudizio da dare sullo stile e sulla tecnica del loro amico e io dissi: "Very good" facendo vedere il mio pollice alzato. Dissi anche "Champion" e tutti scoppiarono a ridere e applaudirono.
I bambini più piccoli a turno salivano in groppa al ragazzo con gli sci, lui se li caricava a cavalcioni uno alla volta e li portava in discesa. Non avevo mai pensato, in vita mia, che lo sci potesse essere uno sport di squadra. In Pakistan, lo è.
Restai lì fuori a giocare e ad applaudire a mia volta queste evoluzioni sugli sci, intanto dalla casa di Aquil ogni qualche minuto lui stesso o un adulto usciva a chiamarmi e a dirmi di entrare a mangiare. "Please, come in. Lunch is ready". I bambini ogni volta mi fissavano in silenzio, per capire se io stavo per andarmene e per lasciarli lì o se sarei restato con loro ancora un po' a sciare, e ogni volta che io rimandavo il momento del pranzo loro si gasavano e caricavano di entusiasmo e di gioia e riprendevano ad andare su e giù dal pendio stando in groppa al più grande di loro.
Penso che quello sia stato uno dei giorni di sci più belli della mia vita e non è stato per merito della neve o degli sci o del pendio o del Nanga Parbat che avevamo appena sopra, nascosto nella nebbia.
E' stato per via di quei bambini pakistani.
Qui c'è un video di quel giorno.
Di tanto in tanto durante la spedizione qualche ragazzo saliva dal villaggio per portare qualcosa, dei rifornimenti, qualche ortaggio o per avere qualche medicinale dei nostri per curare la tosse o l'influenza o semplicemente per farci visita. Un giorno uno di loro, Jamil, era salito con un paio di vecchi sci da fondo per sciare con me. Avevamo speso il pomeriggio a parlare e a girare in tondo su un anello improvvisato sul grande piano di Lattaboo, dove stava il nostro campo. Jamil mi aveva spiegato che quegli sci appartenevano a suo fratello che faceva parte delle troupe speciali dell'esercito pakistano, se li era fatti prestare ed era salito appositamente per sciare con me. Era stato un bel giorno.
Quando iniziammo il cammino di discesa per andare via, dopo le foto di rito con i polacchi che sarebbero rimasti un altro po' per recuperare i loro materiali sparsi sulla montagna, mi accorsi che un gran numero di bambini erano saliti con i genitori o con i fratelli o con gli zii per aiutare nel trasporto a valle dei nostri materiali. Questi bambini mi giravano intorno, curiosi, facendomi tutti la stessa domanda. Gli sci? Dove sono i tuoi sci? Non li vedevano. Dissi che erano nella sacca lunga, quella azzurra e che da qualche parte c'erano gli scarponi, i bastoncini li avevo in mano, li avrei usati per camminare in discesa. Non capivo bene tutto questo interesse dei bambini per i miei sci ma poi, mentre camminavo verso valle mi resi conto che nella desolazione e nella normalità di un luogo come quello, dove l'unica attrattiva fuori dall'ordinario è rappresentata da qualche alpinista occidentale o trekker che può capitare di vedere durante l'estate, io rappresentavo una eccezione. Una specie di alpinista Superman. Io per quei bambini ero uno sciatore, quello che aveva sciato sul Nanga Parbat, non un normale alpinista. Era diverso. Per loro era di più.
Sul sentiero di ritorno davanti a me e dietro a un mulo che ci precedeva un ragazzino che avrà avuto sui quindici anni camminava con uno zainetto sulle spalle e nelle mani teneva due delle cose più scomode che la mia mente possa immaginare da maneggiare e trasportare: una thermos arancione da cinque litri (vuota) e un grosso rotolo di gommapiuma espansa, quella che avevamo usato come isolante sul pavimento della nostra tenda casa. Era un cilindro altro due metri e del diametro di una cinquantina di centimetri tenuto insieme da uno spago, era leggerissimo ma ingombrante e scomodo da maneggiare. Il ragazzino aveva ai piedi un paio di stivali di gomma e procedeva senza lamentarsi con un passo che alternava continuamente tra veloce e lentissimo. Riconobbi lo zainetto che teneva in spalla che era quello che conteneva il computer di Simone, non era né ingombrante né pesante, ma molto delicato, gli era stato affidato per averne particolare cura. A un certo punto, prima di un tratto in salita, dissi a quel ragazzino di darmi o la thermos o il rotolone di gomma piuma, che lo avrei aiutato trasportandolo io. Mi disse di no e si guardò in giro nella speranza che nessuno dei grandi ci avesse sentito. Insistetti un po' perché non mi andava di vedere un ragazzino che poteva avere l'età di mio figlio camminare così scomodo, non erano carichi pesanti, ma erano scomodi da trasportare. Lui non volle.
Dopo un po' mentre la nostra carovana procedeva e camminavamo mi si avvicinò un uomo che era uno zio del ragazzo, non parlava inglese, ma mi fece un gesto con gli occhi per riferirsi al nipote e uno con la mano che avrebbe potuto sembrare "piano", mimava quel gesto con la mano di rallentare, ma che capii che invece si riferiva al ragazzino davanti a noi e che significava "ci vuole pazienza, tu stai tranquillo, non preoccuparti. Lascialo fare." Con i gesti, con lo sguardo e con un unica parola inglese mi fece capire che in tutto questo, nella scelta di assegnare a quel ragazzo quel carico, al tempo stesso leggero e molto scomodo da trasportare, c'era un progetto educativo ben preciso. L'uomo, che avrà avuto la mia età ma che sembrava molto più vecchio mi disse: "learning". Imparare. La parola gli usci a fatica dalla bocca facendosi spazio tra dei denti radi e bianchissimi. Capii perfettamente e annuii. Il ragazzo stava imparando, e così tutti gli altri.
Scendemmo ancora, nevicava intanto, Simone e David scesero a valle quasi di corsa, io restai indietro con i portatori a fare qualche foto e a filmare. Quando fummo a Rupal, dopo qualche ora, individuai nel centro del villaggio la casa di Aquil, ci eravamo già passati a dicembre, in salita, ma ora c'era molta più neve. Fuori di casa su un filo c'era qualche panno steso, tutto intorno a delimitare quelli che d'estate devono essere orti c'erano delle staccionate fatte di rametti secchi e sottili che si sfrangiavano puntando verso l'alto. Una vivace colonna di fumo saliva dal comignolo della casa di Aquil, nella quale era stato preparato un pranzo speciale per noi, mentre nelle altre case vicine, dai comignoli, usciva solo un leggerissimo alito di fumo. Faceva un freddo cane, ma era molto meno freddo che a Lattaboo. Arrivai fuori dalla casa di Aquil e c'erano tutti i bambini del paese ad aspettarmi, in piedi con le mani in tasca. Mi guardavano.
Uno di loro, il più grande, aveva un paio di sci Dynastar ai piedi recuperati chissà dove e un paio di scarponi Nordica a calzata posteriore. I bambini mi chiesero ancora una volta tutti insieme dove erano i miei sci perché volevano che io sciassi con loro, solo che a quel punto la mia sacca con gli sci e gli scarponi doveva aver proseguito verso valle in groppa a un mulo. La delusione fu grande e capii che non potevo cavarmela così. I bambini mi aspettavano da due mesi e mezzo e mi guardavano e si aspettavano qualcosa di speciale da me, così invece che entrare a mangiare dove gli altri mi aspettavano, dissi: "Let's go skiing". Ci fu un immediato animarsi del gruppo e un vociare in una lingua a me incomprensibile e tutti corsero in discesa verso il campetto di neve che c'era appena più in basso. Il ragazzo grande con gli sci prese i bastoncini e iniziò a spingersi e a scendere, pattinando verso valle. In fondo al pendio fece una curva verso sinistra e poi risalì di corsa e fece un altro giro e poi un altro e un altro. I bambini mi guardavano, come per sapere se avevo un giudizio da dare sullo stile e sulla tecnica del loro amico e io dissi: "Very good" facendo vedere il mio pollice alzato. Dissi anche "Champion" e tutti scoppiarono a ridere e applaudirono.
I bambini più piccoli a turno salivano in groppa al ragazzo con gli sci, lui se li caricava a cavalcioni uno alla volta e li portava in discesa. Non avevo mai pensato, in vita mia, che lo sci potesse essere uno sport di squadra. In Pakistan, lo è.
Restai lì fuori a giocare e ad applaudire a mia volta queste evoluzioni sugli sci, intanto dalla casa di Aquil ogni qualche minuto lui stesso o un adulto usciva a chiamarmi e a dirmi di entrare a mangiare. "Please, come in. Lunch is ready". I bambini ogni volta mi fissavano in silenzio, per capire se io stavo per andarmene e per lasciarli lì o se sarei restato con loro ancora un po' a sciare, e ogni volta che io rimandavo il momento del pranzo loro si gasavano e caricavano di entusiasmo e di gioia e riprendevano ad andare su e giù dal pendio stando in groppa al più grande di loro.
Penso che quello sia stato uno dei giorni di sci più belli della mia vita e non è stato per merito della neve o degli sci o del pendio o del Nanga Parbat che avevamo appena sopra, nascosto nella nebbia.
E' stato per via di quei bambini pakistani.
Qui c'è un video di quel giorno.
Etichette:
alpinismo,
nangainwinter,
ski,
telemark,
the north face,
video
Iscriviti a:
Post (Atom)
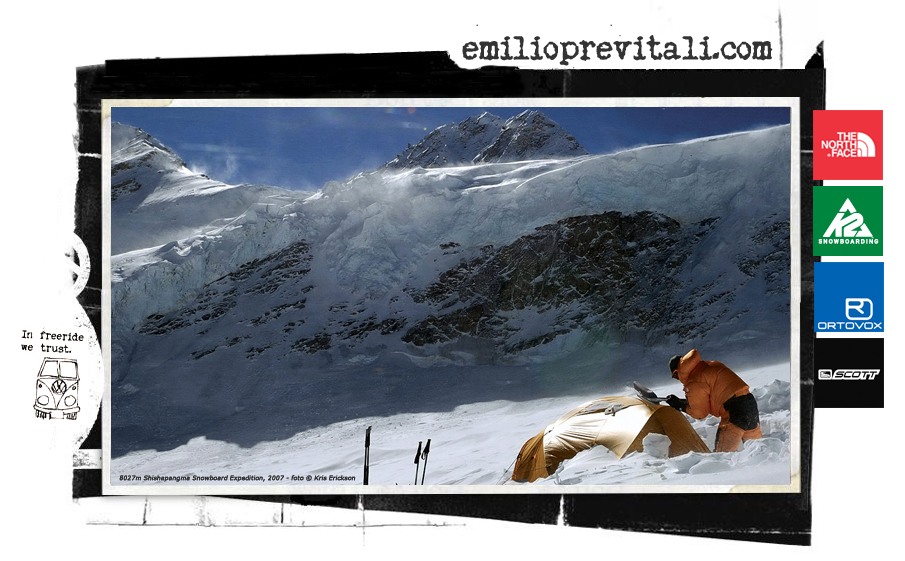






 .
.