Ricordo esattamente, come fosse ora, il giorno in cui per la seconda volta me ne sono andato dal campo base del Cho Oyu. Erano grossomodo le cinque e mezza della mattina. La partenza era fissata per le sette, ma la voglia di andare via era talmente tanta, che alle cinque in punto ero in piedi fuori dalla tenda del mio compagno Zaffa con lo zaino sulle spalle.
Voltato verso valle stavo fermo immobile, in silenzio, in attesa che finisse di ripiegare la sua tenda e di metterla nel bidone. Volevo andare via. Non c'èra alcuna possibilità di provare ancora una volta la cima per via del permesso in scadenza e quei pochi giorni residui al CB erano inutili per fare qualsiasi cosa, sembravano una specie di presa in giro. Ero come prigioniero del tempo. In quel mese che stava per concludersi i giorni trascorsi al vento e sotto la neve bloccati al campo base mi erano sembrati infiniti, eppure alla fine della spedizione non ne erano rimasti abbastanza. Tutta colpa di una data sbagliata sul nostro permesso di scalata. Un timbro di inchiostro rosso su un foglio di carta sgualcita, la ragione più stupida del mondo per terminare una spedizione. Con una ora e mezza di anticipo sul programma, all'alba, senza fare colazione costrinsi Zaffa e gli altri a partire. Iniziammo a camminare in discesa e c'era un silenzio irreale tra noi, tra me e gli altri tre compagni, che scendevano a valle. Io ero in testa al gruppo e stavo correndo, letteralmente correndo giù per la morena. Il Cho Oyu nella penombra del giorno che inizia era alle mie spalle. Forse gli altri provavano lo stesso desiderio di andare via, perché cominciarono a correre anche loro. Sentivo il loro respirare affannato, lo scricchiolare secco e gelido del gore-tex delle loro giacche a vento e il suono dei passi di corsa alle mie spalle. Vedevo le luci delle loro frontali giocare con la mia ombra davanti a me. Era freddo, l'aria trasparente e cristallina, il fondovalle ancora buio e in alto la cima della montagna era certamente di già al sole. Il cielo sopra noi era azzurro e galleggiava sul buio del fondovalle. Una giornata perfetta per la cima. Guardare il Cho Oyu doveva essere uno spettacolo da togliere il fiato, ma io non mi girai mai a guardarlo, nemmeno una volta. Nemmeno per un secondo. Vaffanculo. Correvo verso valle e fissavo unicamente i miei piedi muoversi sul sentiero, il mio non era un ritorno, stavo scappando.
Ad un certo punto arrivai in corrispondenza di una grande pietra, un enorme masso morenico davanti a cui il sentiero svolta secco a destra e scende più ripido. Sapevo esattamente che quello era l'ultimo punto per vedere il Cho Oyu così come lo si può vedere soltanto dal campo base. Andare oltre significava abbandonare l’atmosfera senza tempo del campo base, uscire per sempre dal palcoscenico dalla mia piccola storia con quella grande montagna. In quell’istante, all’improvviso, mi venne in mente mio padre nel giorno in cui lo accompagnai all'ospedale dove andava a morire. Sapevo esattamente che non sarebbe più tornato a casa e credo che lo sapesse anche lui. Era debole e magro, stava a letto da qualche mese con delle metastasi al fegato e si reggeva a malapena sulle gambe. Ricordo la sua mano magra e scavata afferrare la ringhiera delle scale e stringerla. Con l’altra mano si appoggiava al muro nel tentativo di fare tutto da solo, capii che non voleva essere aiutato. Esitò per qualche istante sul pianerottolo, poi alzò lo sguardo e guardò fuori dal lucernario delle scale per qualche interminabile secondo, anche quella era una gelida mattina fredda d'inverno. Avvertivo il frusciare del suo respiro, io ero lì dietro di lui, al posto dove un figlio deve stare, un passo indietro. Lo vidi iniziare a scendere le scale quasi di corsa, sembrava un gesto impossibile e pazzo per uno che si regge a malapena in piedi. Lo osservavo sbalordito. La coordinazione dei movimenti era perfetta per quanto il suo cancro si fosse divorato tutti i suoi muscoli. Controllai bene e vidi che mio padre non alzò mai lo sguardo verso la porta di ingresso della sua casa, nemmeno quando la rampa di scale cambiando direzione lo obbligò a girarsi. Non si voltò mai indietro, mai, fissava solo i suoi piedi. Fece tutto da solo e scese di corsa senza voler essere aiutato tutti i centoquattordici gradini che conducevano a terra poi, con dignità, prima di uscire in strada si lasciò aiutare da me e da mia mamma. Era esausto, svuotato di tutte le energie.
Nella mia mente lui è morto lì, in quel momento, tutto il resto è stata distaccata e silenziosa agonia. Il suo era un tentativo di fuga dal destino inevitabile. Oppure un test, scendere quelle scale doveva essere grossomodo come scalare una delle tante montagne che aveva salito in vita sua. O forse, più semplicemente, era desiderio di giungere alla sua destinazione finale il prima possibile. Comunque fosse, stava scappando. Quel giorno in discesa dal campo base del Cho Oyu pensai a mio padre e a quella storia o meglio a quella sensazione di ultima volta e di impotenza che si impadronì di me per una frazione di secondo e allora mi fermai. Esitai per qualche secondo davanti a quella gigantesca roccia morenica e poi mi voltai verso monte. Sollevai lo sguardo ed il Cho Oyu era lì, immenso, scintillante in una luce quasi irreale. Anche i miei compagni si fermarono e si girarono. Restammo tutti e quattro in silenzio per qualche secondo, forse per qualche minuto, non so. In quell'istante, per davvero, il tempo si era fermato. Appena ripresi a scendere, senza mai più voltarmi e senza mai parlare, una domanda cominciò a ronzarmi nella testa: "Tornerai ancora, qui?” "Tornerai ancora, qui?”.
Da allora tante cose sono successe, ho scalato e fatto snowboard su tante altre montagne, i miei figli sono cresciuti, mi sono occupato di tante cose belle e interessanti. Nel tempo ho imparato a mettere da parte l'urgenza di dare una risposta a quella e a tante altre domande, diluendo l’insuccesso di una spedizione in tante buone ragioni per considerare le montagne semplicemente per quello che sono: ammassi di roccia, neve e ghiaccio. Siamo noi che ne facciamo qualcosa di speciale, se riusciamo a comprendere la storia che ci lega a loro, indipendentemente dal punto più alto che riusciamo a raggiungere. La mia storia personale passa di là, davanti a quel gigantesco masso morenico ai piedi del Cho Oyu. Per questo anche se a qualcuno può sembrare stupido o strano o senza senso torno per la terza volta sulla stessa montagna: perché ho capito che io sono la mia storia.
E’ là che devo andare, adesso.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
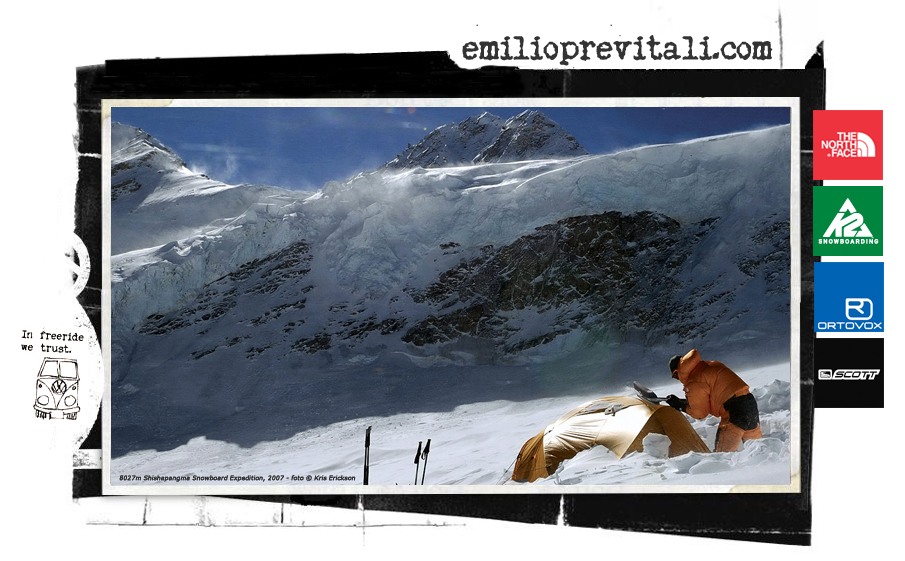




 .
.
Nessun commento:
Posta un commento