Non lo so da quanto è che non prendo un autobus. Un autobus
di linea, dico. E’ tantissimo.
Dagli undici ai quattordici anni ne ho preso uno tutti i
giorni. Tutte le mattine. Uscivo di casa da solo e me ne andavo a piedi alla
fermata in fondo alla strada. Aspettavo l’autobus numero 4 oppure l’11. Stavo
lì in piedi ad aspettare con lo zaino in spalla, tutto proteso in avanti in una
posizione rigida e stranissima, inclinato in avanti fuori squadra, e certe
volte mentre ero lì e mentre mi guardavo la punta delle scarpe e guardavo
quelle chiazzze bianche che sono i chewin-gum incollati e rinsecchiti a terra, mi
chiedevo perché io andavo in una scuola in centro alla città e non nella scuola
che avevo di fronte a casa, dall’altra parte della strada. Esatto, ne avevo una
proprio di fronte a casa, di scuola. Esattamente di fronte. Era lì che avrei
dovuto andare io, è lì che sono andati tutti i miei compagni delle elementari.
In quella scuola. Io andavo in centro, invece.
Poi alle sette e zero4 l’autobus puntualmente arrivava, e quei pensieri e quelle
domande svanivano. L’autobus si fermava e davanti a me si aprivano le porte e
c’era quello sbuffo di aria calda che mi investiva. Scarpe di gente in piedi e
orli di pantaloni e punte di ombrelli girate all'ingiù. Due gradini da fare per salire, uno più basso e uno
più alto. Entravo e prendevo il mio spazio e c’erano quegli sguardi, tutti gli
sguardi su di me. Io ero il più piccolo. Il più piccolo di tutti. Stavo zitto, abbassavo
la testa e ricominciavo a guardarmi le scarpe. Le porte si richiudevano alle
mie spalle e l’autobus ripartiva, c’era quella specie di balzo in avanti del
motore, come se tutti noi fossimo in piedi su un asse di legno che rotola via
sopra una palla di gomma e poi il moto uniforme. Tenendo le mani nelle tasche
del cappotto mi aggrappavo con l’interno degli avambracci e dei gomiti a quei sostegni, e mi puntavo con l’esterno della coscia tentando di non toccarli mai con
le mani quei tubi, perché mi facevano schifo. Tutti li toccavano con le mani.
Mani sporche, pulite, luride, sudate, sudaticce, secche, screpolate, gommose, morbide
per via della crema, o anche viscide sempre per via della crema idratante se per
caso qualcuno ne aveva messa troppa, di crema. A me facevano schifo. Io non li toccavo
quei pali. Non con le mani.
Poi si arrivava ad un'altra fermata, la successiva
e le porte si aprivano un’altra volta e saliva qualcun altro. Gli sguardi erano
per lui, o per lei adesso, il nuovo o la nuova arrivata. Finalmente. Finalmente
potevo sparire. Essere di nuovo io, essere nessuno in mezzo a altri nessuno. Poi
bastava solo aspettare un po’ancora fino alla fermata di Porta Nuova in centro alla città e lì mi sarei liberato anche di loro, di tutti loro, di tutte quelle facce, di
tutti quei nessuno. Sarei rimasto da solo sull'autobus con tutte le sedie vuote e quei finestrini liberi e avrei
proseguito il mio viaggio per altre due fermate prima di scendere, prima di
fare un altro pezzo di strada a piedi sempre da solo - un tratto in salita
ripida in cui camminare ancora più ridicolamente fuori squadra e proiettato in
avanti con il collo e con la testa - e arrivare a scuola. Entrare nella scuola.
Mettere la mia roba nel mio armadietto. Prendere i libri, mettermi in fila con
gli altri. Fare finta di recitare una preghiera muovendo la bocca. Salire in
classe stando in fila per due. Sedermi, finalmente, nel mio banco vicino al muro. Dall’altra
parte dell'aula, alla mia sinistra, avevo una grande, enorme finestra oltre cui
guardare tutte le volte che volevo. Oltre le teste dei miei compagni punte di alberi sempreverdi. Spigoli di case e finestre
sempre chiuse. Tetti di tegole rosse e rosa, o rosso scuro se per caso pioveva.
Un pezzo di cielo a volte azzurro, altre volte bianco, altre volte grigio. Il profilo di
Città Alta sullo sfondo. Aria, tanta aria nel cielo sopra la città e sopra alle
case e dietro alla punta degli alberi a tenere insieme come collante tutto quanto quel quadro.
La mia classe era in alto, al quarto piano e della città o meglio del quartiere, io potevo
vedere solo i piani alti e i tetti, la parte misteriosa e silenziosa della città, cioè tutto quello che dalla strada non si
riusciva a vedere.
Mentre ero in classe e uno qualsiasi dei miei professori faceva lezione io riuscivo a isolare e a riconoscere il rumore dell’autobus
che giù in strada arrivava da lontano, da dietro, da in fondo alla strada e che si arrestava alla fermata che
c’era davanti alla scuola, sotto alla grande finestra oltre la quale guardavo.
C’era il motore dell’autobus che scendeva di giri, quel suono pneumatico delle
porte che si aprivano, sempre quello, il solito. Immaginavo altre scarpe, altri
orli di gonne o di pantaloni, altre borse in pelle tenute in mano, altre punte di
ombrelli chiusi puntate sul pavimento del bus. Gente che scendeva e gente che saliva. Anche io salivo su
quell’autobus. Me ne andavo via. Il mio professore o la mia professoressa
parlavano con quella parlata lenta e noiosa e continuavano a parlare e io
andavo via, li lasciavo lì. Mentre loro spiegavano io mi facevo dei giri in
autobus per la città. Il paesaggio che scorre normalmente fuori dai finestrini
degli autobus, case, alberi, negozi, panchine, insegne luminose, gente che cammina, cani al guinzaglio, cartelli pubblicitari, motorini, auto che vanno in direzione contraria scorreva davanti ai miei occhi, e io invece che vedere la lavagna
e la cattedra e il cestino della carta e i miei compagni che restavano in equilibrio sulle gambe posteriori della sedia e la messa in piega della mia professoressa che si dondolava nell’aria e le palline di maglia che si raggrumavano sui gomiti e sui fianchi del
suo vecchio maglione di lana vicino alle tasche, invece che vedere gli sputi della sua
saliva che perdevano peso nell’aria e che venivano intercettati dalla gravità e
che si schiantavano sulle piastrelle del pavimento, sui miei libri, sulle copertine dei miei quaderni, sul mio banco, dappertutto,
viaggiavo. In autobus. Con la fantasia.
Io adesso li odio, gli autobus.
Certe volte dopo la fermata in Porta Nuova, quella dove
scendevano tutti, e dopo le altre due fermate ancora, quando arrivavo a quella
a cui dovevo scendere io di fermata, avrei voluto rimanere sull’autobus e
andare avanti. Sorprendere l’autista restando a bordo e andare a vedere fino a dove lui e l’autobus andavano a finire. Vedere un altro pezzo di città e in definitiva un
altro pezzo di mondo che io non conoscevo. E una volta l’ho fatto.
Alla fermata dove dovevo scendere, una mattina, non sono
sceso. L’autista mi ha guardato, mi ha fissato con quello sguardo che fanno gli
autisti degli autobus vestiti di blu con la camicia azzurra quando rimani da solo in vettura con loro e anche io l’ho
guardato, l’autista. Non mi sono guardato la punta dei piedi, quella volta. Ho
guardato lui, dritto negli occhi. Allora lui ha dato un occhio allo zaino che
avevo sulle spalle e poi mi ha riguardato negli occhi e poi ha girato la testa, ha guardato
alla strada davanti a noi e ha spinto con le dita su quei tre piccoli pulsanti
verdi illuminati, erano dita grassocce bianche e pelose le sue, con quelle unghie
squadrate bordate di bianco, le luci verdi si sono spente, c'è stato ancora quello sbuffo pneumatico e poi le porte si sono richiuse. L’autobus è ripartito
con il solito balzo in avanti e abbiamo fatto altre tre fermate. Le porte si
riaprivano e si richiudevano, entrava dell'aria ma non saliva più nessuno.
Poi a un certo punto
l’autobus si è fermato in uno spiazzo largo in un luogo che non conoscevo e l'autista ha strillato Capolinea, non ci sarebbe stato nessun bisogno di
strillare, io ero l’unico passeggero rimasto sull’autobus ed ero di fianco a lui. L’autista mi ha
fissato e mi ha detto Si scende, questo mezzo va in deposito. Allora io sono
sceso. Mi sono aggrappato a quei tubi di alluminio, per una volta
infischiandomene del rischio di toccarli con le mani. Li ho stretti con le dita, erano freddi, meno lisci al tatto di come me li ero sempre immaginati.
Ho fatto quei due gradini in discesa, la pianta dei miei piedi è passata dalla
sensazione dei passi gommosi su quel pavimento fatto di righe chiaroscure in rilievo che
c’è su tutti gli autobus di linea, al rassicurante grigiore ruvido dell’asfalto asciutto.
Un ondata di aria fresca e pulita mi è venuta incontro sul volto e sulle mani, e sul collo.
Davanti a me c’era una un marciapiedi largo, una pensilina con i vetri sporchi
e dei ciclostilati in proprio raggrinziti incollati con il Vinavil ai vetri della pensilina; e
un tubo giallo che svettava lì a fianco, con gli orari degli autobus scritti
sopra a dei fogli di carta in carattere Courier corpo 8 dentro a una bacheca
con una protezione in plexiglas ingiallita. Il bordo della bacheca era in
lamiera di metallo, tagliato e saldato a 45° negli angoli.
C’era una donna
anziana che camminava sul marciapiede dondolandosi a destra e a sinistra, trascinava i suoi passi spugnosi tenendo delle borsine di plastica in mano con dentro
la sua spesa, poche cose. Sacchetti azzurri anonimi. Io mi sono guardato in
giro. In quel posto non c’ero proprio mai stato. Ho immaginato più o meno la direzione
in cui doveva trovarsi la mia scuola, in linea d’aria ho cercato di capire dove poteva essere e ho
cominciato a correre.
Ho cercato la mia strada e l’ho trovata.
Alla mia scuola sono arrivato, soltanto un po’ in ritardo.
Nessuno mi ha sgridato per questo. Nessuno se ne è accorto. Poteva andare male
e poteva andare bene, è andata bene.
Quella è stata l’ultima volta che sono andato a scuola in
autobus. Dopo quel giorno ho iniziato ad andare in bicicletta, che ci fosse il
sole o che piovesse, che nevicasse, che tirasse vento o che non ne avessi
voglia, di pedalare.
Da quel giorno ho iniziato a essere libero.
---
Questo è l’ultimo post che scrivo. Facebook e internet e il mio blog,
per un po', non li userò più. Magari solo una volta ogni tanto, non lo so. Solo
cose brevi, o brevissime, comunque. Brevi note. Link. Appunti veloci.
Questo per la mia voglia di scrivere è il momento di smettere di scendere sempre alla solita fermata e provare ad andare un po’ più in là. Un po’ più avanti. Fare un’altra strada, una diversa, una nuova che non conosco. E’ il momento di farsi coraggio e di andare a vedere cosa c’è più avanti e provare a vedere se sono in grado di trovare un'altra strada da solo, una che mi riporti a casa se ne ho voglia o dove ho voglia di andare. Voi se volete, se avete voglia o bisogno di parlarmi, potete scrivermi - mi fa piacere - o telefonarmi o venirmi a trovare di persona. Il mio numero lo avete. La mail anche, è sul blog.
Adesso vado. Sono da qualche parte qui intorno. Che scrivo, che mi alleno, che faccio le mie cose.
Quelle a cui tengo.
Ciao, e.
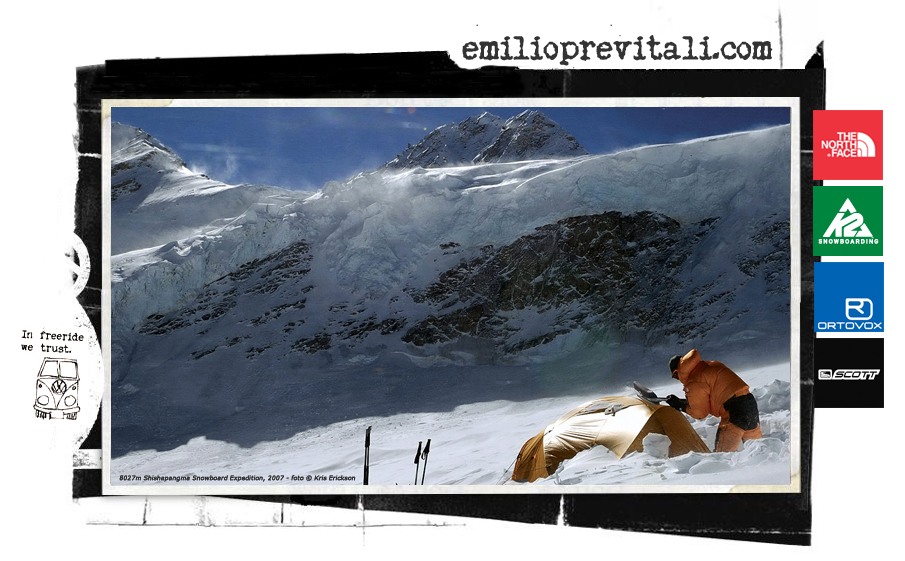




 .
.
Nessun commento:
Posta un commento