Io ho una serie lunga di difetti tra questi alcuni gravi, altri meno gravi. Tra i difetti gravi c’è questo: io odio i trolley. Sarà un difetto grave questo? direte voi, odiare i trolley? io penso di si. Gravissimo.
Odiare i trolley è il risultato di un percorso di pensiero, non è un odio epidermico il mio, superficiale od occasionale ma il risultato di osservazioni, riflessioni, analisi approfondite. E’ un odio scientifico e motivato. Io credo che il grado di evoluzione (o involuzione di un popolo) abbia come unità di misura il trolley. Più ce ne sono in giro, più il destino di un popolo è segnato. Irreversibile. Sei esagerato, direte voi. No, non esagero.
Questa mattina mi sono svegliato presto, verso le 5.30, una delle mie due figlie partiva per una gita scolastica, il compito di portarla al pullman spettava a me. Mi sono alzato, lavato e vestito e quando sono stato pronto sono entrato nella stanza di mia figlia per vedere se era pronta anche lei, era quasi pronta. Quasi. Ho visto pronto sul pavimento della stanza un trolley, mi sono messo subito di cattivo umore. Senza aggiungere una parola sono sceso da basso (c’è un piano di scale da fare) e sono andato ad accendere la macchina e a portarla sotto casa, a quel punto mia moglie ha completato i preparativi di partenza di mia figlia, sembrava che dovesse andare sulla luna con lo Space Shuttle, non a Chianciano Terme con il pullman.
Ho sentito un rumore sordo di plastica che rimbalzava giù per le scale e poi Anna è arrivata, dietro il trolley. E’ salita in macchina, ha chiuso la portiera (le sono serviti due tentativi) e siamo partiti alla volta della scuola, mentre stavamo andando mi ha detto che si era dimenticata di ricaricare il telefonino e aveva solo il 7% di carica. “Tanto non mi serve, ho tutto” mi ha detto. Mi sono tirato un po’ su di morale, dentro di me si è disegnato un sorriso, nutrivo la speranza che quel 7% si tramutasse presto in un 5%, poi un 3%, poi in uno zero. Batteria morta. Silenzio. Ho chiesto se aveva preso il caricabatteria, speravo di no, lei forse invece, mia figlia, voleva rassicurarmi, Sì, l’ho preso - mi ha detto - tranquillo. E’ nel trolley. Mannaggia. Ero più tranquillo se non ce l’avevi. Mi sono messo di nuovo di cattivo umore.
Siamo arrivati quasi alla scuola e nel blu del mattino presto le luci gialle dei lampeggianti pulsavano nel cielo arrampicandosi sui muri delle case, riflettendo quella luce itterica (itterica si dice?) e intermittente. Pensavo all’autocisterna del comune che lavava le strade. Sbagliato. Erano le quattro frecce di una quantità spropositata di autoveicoli parcheggiati in disordine in doppia fila in prossimità della scuola, più che la scuola media di Scanzorosciate pensavo di essere capitato in mezzo a un episodio di “Sulle strade di San Francisco” con auto di traverso dappertutto, auto sui marciapiedi, c’era una quantità assurda di madri eccitate già truccate già sui tacchi già vestite da matrimonio e già perfettamente pettinate e piastrate che aprivano e chiudevano portiere di automobili, anteriori e posteri, bauli, forse anche cofani e sportellini della benzina, tutto quello che si poteva aprire dentro a una automobile era aperto, alette parasole comprese. Anche gli sportellini posacenere, aperti, credo.
Mentre cercavamo di avanzare in quella giungla di portiere aperte (pensare di fermarsi o parcheggiare o peggio ancora tornare indietro in retromarcia fino all’altro parcheggio libero era impossibile) cercando di non portarcene a casa qualcuna, di portiera, sulla destra della strada una lunga fila di studenti quattordicenni avanzava trascinandosi dietro ciascuno il proprio trolley. Dietro alla nostra auto, altre auto. Illuminati da dietro alla luce degli anabbaglianti lo spettacolo era inquietante e al tempo stesso suggestivo, ombre nere di ragazze e ragazzi adolescenti che avanzavano accompagnati da quel rumore sordo di rotelle che giravano sull’asfalto e che in un ritmo ondivago si amplificavano rimbalzando tra i muri delle case. Villette, pardon. Villette mono e bifamiliari.
Siamo arrivati in prossimità della scuola, io ho a mia volta imboccato il l’anello di inversione di marcia sul piazzale antistante la scuola contromano, era l’unico posto dove potevo andare, il traffico era già intasato e stavo a mia volta intasando il traffico seguito da un altro numero imprecisato di auto intasatrici guidate da altrettanti genitori intasatori conducenti alla partenza della gita scolastica il relativo figlio o figlia trolley-munito.
Ho parcheggiato e sono sceso dalla macchina. Abbiamo scaricato il trolley, lo abbiamo posato a terra, mia figlia con un gesto fluido ed elegante ha estratto il manico telescopico del trolley e lo ha aperto. Io ho provato il desiderio di sbilanciarlo e buttarlo fuori equilibrio spingendolo per terra con un colpo, quel cazzo di trolley, ma mi sono trattenuto. Ciao Anna, ho detto. Divertiti, lei mi ha sorriso. Nel frattempo una corte di amiche e amici quattordicenni le se era fatta incontro, ciascuno con il proprio trolley al seguito. Si sono abbracciati e baciati tutti come se non si vedessero da mesi, c’era un vago odore di chewing-gum alla menta nell’aria. Mentre ero lì e guardavo Anna allontanarsi e andare verso il pullman mi chiedevo se erano i ragazzi che si portavano dietro l trolley, o se erano il trolley che si tenevano loro al guinzaglio. Secondo me la seconda.
Io mi ricordo la prima volta che sono andato via da casa da solo per due giorni. Mio papà mi aveva dato uno zaino e io lo avevo riempito di cose, utili ed inutili. Quelle inutili servivano a tenerlo pieno e a dare volume ma soprattutto a sottolineare il senso del viaggio - due giorni da mia zia Grazia a Zogno, in valle brembana - servivano a confortare la mia autostima personale e a fornire la consistenza necessaria al mio pensiero di piccolo viaggiatore. In un viaggio serio il bagaglio deve essere un bagaglio serio, altrimenti che bagaglio è? e che viaggio è? Mentre ero lì in piedi e guardavo questi cuccioli di uomo e di donna pensavo a come siamo cambiati. Una volta lo zaino in spalla o una borsa a tracolla erano il il simbolo della libertà e del cambiamento, erano il simbolo della ribellione e del rifiuto del mondo dei vecchi - il mondo dei vecchi era il mondo delle valige. Ricordo decine Citröen Dyane o 2CV che sul portellone posteriore del bagagliaio avevano quell’autoadesivo di quel ragazzo con i capelli lunghi biondi che con una borsa a tracolla se ne andava per il mondo. Libero. Lo vedevi sempre di spalle quel tizio, voglio dire non esisteva una versione dell’adesivo di lui preso di fronte. Lo vedevi sempre da dietro perché sempre se ne stava andando. Via. Da qualche parte, lontano. In viaggio.
I trolley sono il simbolo della rinuncia, dell’adeguarsi. Sono il simbolo della rassegnazione e il fatto che ai ragazzini di 14 anni piacciano più delle borse o degli zaini da mettersi in spalla dovrebbe dirci un sacco di cose. Che questi ragazzi non sognano più di essere liberi o ribelli, di andare lontano. Sognano di essere come gli altri. Di adeguarsi al sistema. Di restare. Come i genitori, i fratelli, i nonni e gli zii. Sognano di essere omologati, di non discostarsi dalla uniformità, dalla media. Sognano il destino che qualcuno ha o dovrebbe avere disegnato per loro, peccato che non c’è niente di pronto e di preparato in questo paese, a parte i sogni. Non è rimasto quasi più niente. I ragazzi non sognano falò in spiaggia suonando una chitarra - trascinatelo te, un trolley in spiaggia - non sognano i campeggi polverosi della Toscana, i prati fangosi in mezza costa che conducono alla baita di uno zio di un amico per stare insieme e ubriacarsi, non sognano qualcuno che li faccia innamorare e li rapisca portandeseli via in moto (portatelo te un trolley, in moto). Sognano delle immense praterie piastrellate in cui trascinare docilmente i loro trolley con una mano mentre con l’altra scorrono i messaggi sullo schermo del telefonino.
Forse esagero.
Forse, no.
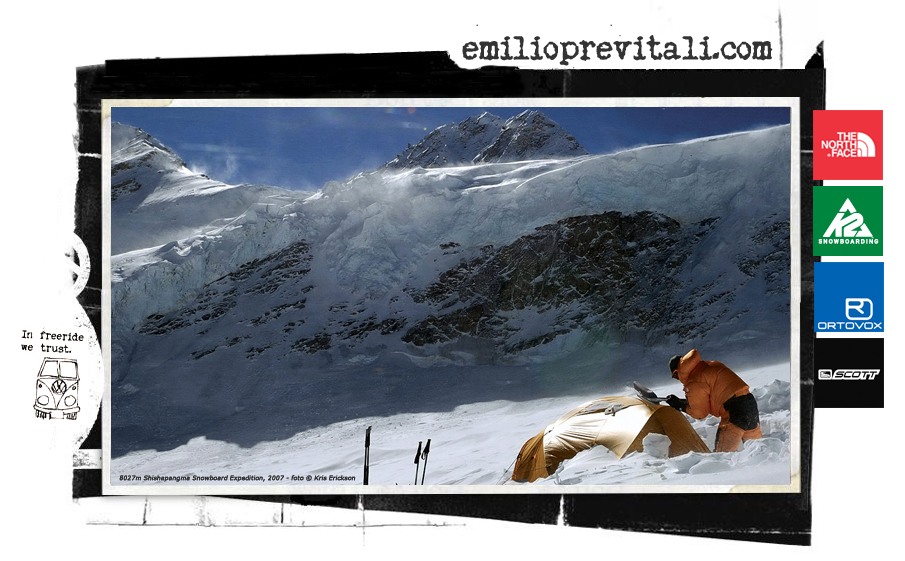




 .
.
Nessun commento:
Posta un commento